“All my sons”
(Arthur Miller)
In una cittadina della provincia americana, nel giardino posteriore della sua casa, l’industriale Joe Keller, un uomo robusto sulla sessantina, si gode la domenica mattina con i suoi vicini, il dottor Jim Bayliss e il merciaio Frank Lubey. Parlano di un po’ di tutto, i tre uomini: di un albero che il vento della notte ha spezzato, degli annunci economici che incuriosiscono Frank, delle petulanti richieste di visite mediche per il dottor Jim Bayliss. Ma parlano anche di Ann, una stupenda ragazza che è venuta a passare il week-end in casa Keller e che era, fino a tre anni prima, la fidanzata di Larry, il figlio di Joe morto in una missione di guerra.
Hanno un altro figlio, Kate e Joe Keller: Chris, che lavora nell’industria paterna che fornisce l’aviazione militare per le teste di cilindro dei motori.
Quell’albero spezzato era stato piantato quando i Keller avevano avuto la notizia che Larry era stato considerato disperso e ora, che di quell’albero non resta niente, si rinnova tristemente il sospetto, per non dire la certezza, che Larry sia disperso perché sciaguratamente morto. Lo sa Joe, Chris, persino Ann: solo la madre, Kate, è convinta che quel figlio possa ancora ritornare, dopo tre anni di assenza. Ma la storia, anzi l’antefatto è più complesso: quelle teste di cilindro furono montate difettose sugli apparecchi da Steve Deever, padre di Ann e socio di Joe: non c’era tempo per verificarne la tenuta perché la committenza dei militari aveva fretta di far decollare gli aerei, altrimenti sarebbero stati annullati l’appalto e il pagamento. Caddero ventuno aerei nei cieli d’Australia, tutti equipaggiati con quelle attrezzature inaffidabili e il padre di Ann fu incriminato per quella omissione colposa e sta tuttora scontando in carcere la sua pena.
Il “prima” è stato delineato, inquadrato e scrupolosamente raccontato da tutti: ora si tratta di vivere il “dopo” ed è nel dopo che si sviluppa l’azione di Erano tutti miei figli (traduzione di Bruno Fonzi), che il drammaturgo americano Arthur Miller scrisse nel 1947.
La morte di Larry, per quanto prematura, non ha creato struggimento in quanti lo amavano: è stata vissuta come una dolorosa fatalità ma il tempo – i tre anni passati – ha modificato rimorsi, rancori, rivalse. La colpa e la pena inflitte al padre di Ann hanno fatto sì che si andasse oltre, che si rimuovessero quelle ossessioni persecutorie provocate di solito da un evento così crudele come può esserlo la morte di un giovane uomo. C’è bisogno quindi di pensare al presente, al futuro e di recuperare e risolvere quella opaca malinconia che serpeggia come un nefasto presagio.
Chris, per esempio, è innamorato di Ann, forse lo era anche quando il fratello Larry era vivo e Ann, mai forse perdutamente presa di Larry, rivede e riconosce in Chris il suo compagno d’infanzia e l’uomo che potrà renderla felice: Ann, infatti, parla di matrimonio. Joe vede di buon occhio la relazione di Chris con Ann e pensa che quella ragazza che conosceva da bambina, e che ora è una donna fatta, potrà comunque restare in famiglia e perpetuare con l’altro figlio la medesima gioia di vivere. Chi è contraria a tutto questo è Kate: ottenebrata da continue e lancinanti emicranie, Kate non accetta la morte del figlio Larry, non accetta la presenza di Ann e, men che meno, il progetto che Chris e Ann fanno intendere di coltivare e compiere in un’esistenza comune. Kate, tuttavia, è lucida e sentenzia che la ragazza di Larry non può diventare la moglie di Chris. Per conto suo, Chris cerca di essere equilibrato, di evitare attriti con la madre, pur non compiacendola, e di realizzare con Ann quel sentimento che covava segreto da anni. La stessa Ann sembra liberata da una promessa che non ha più senso giacché non si ritrova nella sorte incresciosa della vedova bianca.
Ma c’è un non-detto in questa storia e Arthur Miller sviluppa il suo dramma non solo su ciò che è successo dopo l’evento-causa (la morte di Larry), ma soprattutto su ciò che si agita nelle coscienze dei protagonisti come un’insidiosa malìa, che costringe tutti ad affrontare senz’altri infingimenti una verità o una menzogna. Arthur Miller dipana il mistero con sequenze di richiami, di dettagli, di riflessioni che eludono sempre, di volta in volta, una soluzione catartica, sebbene non facciano altro che presagirla. Lo stesso Miller dichiarò che “All my sons” aveva un tratto ibseniano e la costruzione drammaturgica di questa storia sul serio fa pensare ad un conflitto intimo e tuttavia trascurato, offuscato paradossalmente da un’assenza di pathos, dall’assenza di un motivo rigenerante, da uno scatto di orgogliosa lucidità.
L’evento-nucleo di questa vicenda è la presenza di Ann e tutto ciò che questa giovane donna addìta e allude per l’integrità familiare dei Keller. Ann non rimugina sulla colpevolezza del padre, si affida a quanto dichiarò Joe all’epoca del processo e alla promessa che le fece Joe di riassumere in fabbrica il padre una volta scontata la pena. Potrebbe sembrare cinismo, il suo, o ingenerosa disaffezione filiale ma Miller ci fa capire come l’atteggiamento di Ann sia quello più realistico rispetto a quelli patetici degli altri: certamente più dell’accorato Chris, dominato dalla figura carismatica del padre e da quella ingovernabile della madre Kate, ingabbiata in una mestizia intoccabile da vestale del tempio.
Nemmeno l’arrivo di George, fratello di Ann, scardina quest’atmosfera di indefinibile apatia e di controversa rassegnazione. Ma qualcosa si muove: i vicini – Sue, la moglie del medico – cominciano a parlare, a trasmettere dubbi che in realtà sono prove inconfutabili: che era stato Joe a infangare il socio Steve accusandolo ingiustamente di negligenza e che era stato Joe a far passare per affidabili quelle apparecchiature difettose.
A difendere Joe intervengono senza troppa convinzione un po’ tutti: c’è da apprezzare la probità di Joe Keller che ha sempre lavorato per il bene di tutti, riscuotendo per questo invidia e malignità. E il non-detto comincia a svelarsi benché aleggiasse molesto negli animi di Ann, di Chris, di George e della stessa Kate. Ann mostra una lettera che Larry le scrisse il giorno che morì: Kate prova a bloccarla, con il presentimento di un’atroce verità, ma Ann la consegna a Chris perché la legga a tutti ma, soprattutto, a Joe. In quella lettera Larry descriveva l’angoscia sofferta alla notizia del processo, ben sapendo che era stato il padre Joe a non occuparsi dei necessari controlli a quelle apparecchiature, inducendo il socio Steve ad approntare dei rimedi occasionali, scaricandogli infine la responsabilità dell’intera operazione truffaldina.
L’aereo su cui volava Larry non era difettoso e tuttavia, per la vergogna e l’orrore provato per il padre, Larry si lasciò morire come morirono quei ventuno piloti degli aerei maldestramente assemblati. Questa rivelazione sconforta ancora di più sia Kate che Chris, ne irrita la compassione e li fa sprofondare nella più cupa disperazione.
A questo punto si resta sorpresi e sconcertati per quanto è finora successo: Arthur Miller ha condotto gli spettatori di questo dramma in una sinuosa spirale di accuse larvate e latenti, di convincimenti fatti passare per ipotesi e opinioni arbitrarie, dettate dall’invidia e dalla gelosia. Tutti accusano Joe Keller ma non se la sentono di dirlo esplicitamente e noi spettatori cominciamo a farci una ragione, a tirare delle conclusioni sul comportamento e sul passato di Joe. In realtà siamo stati fuorviati, per la suggestione drammaturgica, dal non-detto dei personaggi e avevamo assegnato questa reticenza a tutti tranne che all’eroe eponimo o negativo dell’intera vicenda, a Joe Keller.
Miller costruisce questa finissima tela di ragno, quest’orditura del silenzio mentre ci presenta l’albero spezzato, la voglia di vivere di Ann, l’incertezza e la generosità di Chris e l’apparente svagatezza di Kate. Tutti hanno parlato, ricordato, insinuato e giudicato la manomissione delle apparecchiature, il processo e la condanna del padre di Ann e George, persino il calcolo fatto da Frank Lubey sull’oroscopo di Larry che non sarebbe dovuto morire perché il giorno che scomparve era il suo giorno fausto… Tutti ma non Joe. Il patriarca, il padrone, l’uomo sicuro di sé non ha replicato, non ha sentito il bisogno di difendersi, se non altro, dalle maldicenze. Joe Keller, nella drammaturgia di Miller, anticipa i caratteri di uomini infelici o gelosi come Willy Loman (“Morte di un commesso viaggiatore”, 1949) o Eddie Carbone (“Uno sguardo dal ponte”, 1955): l’abitudine o la tendenza a sdrammatizzare o a interagire con passione, anche a costo di stravolgere la realtà e i sentimenti.
Prototipo del self-made man, Joe Keller fa capire che non ha nulla da nascondere, che ha sempre lavorato per la famiglia e la comunità del loro quartiere, che ha accumulato e prodotto “denaro buono e pulito”, che lascerà la fabbrica al figlio superstite e che sopporta i veleni degli altri – anche della moglie Kate – perché li ritiene inevitabili quando qualcuno come lui ha reso possibile l’esistenza di tanti, di tutti. Ma ora si tratta di rendere praticabile e degna la sua di esistenza, il suo primato di industriale infìdo, di padre incompiuto, di marito distratto, di vicino di casa emarginato. Stavolta tocca a Joe Keller dipanare l’imbroglio di quella fornitura per gli aerei da guerra, di svelare a se stesso il segreto che aveva rimosso e, per un uomo come lui, svelarsi non è come scoprire le carte di un giocatore.
Sottoposto da Chris a un furioso interrogatorio sulla vicenda della truffa e un’aleatoria ipotesi di riabilitazione, Joe si affida ad una candida conclusione, sicuro che l’aviazione avrebbe scoperto i difetti e che lui avrebbe provveduto a porvi rimedio. Chris, fuori di sé, non si convince, non può condividere quella che gli sembra un’ulteriore e deleteria ammissione di colpa. Comincia a frantumarsi il mondo intorno a Joe, quel mondo fatto di buoni propositi, di un’intera vita dedicata al lavoro, di un’esistenza sul filo del rasoio, di affetti in bilico e in rovinosa caduta. Il suo equilibrio di uomo e padre sta per vacillare, scopre di ritrovarsi e di sentirsi solo, solo con le sue aspettative e solo con i suoi sogni mancati.
Sopraffatto da un’inquietudine che non conosceva e da un rammarico che non aveva mai provato, tocca a Joe Keller discolparsi e rendere giustizia, fra gli altri, al figlio Larry disperso perché sacrificatosi in nome del padre. Joe Keller dichiara che ammetterà la sua colpa davanti ai giudici e che quei piloti caduti, come Larry, erano tutti suoi figli. Joe si ritira in casa per vestirsi e dopo un po’ si sentirà un colpo di pistola.
Il suicidio di Joe raggela tutti: è la conferma di un’ingiustizia perpetrata e di un’auto-distruzione che, per quanto improvvisa e imprevedibile, non poteva non compiersi. Chris andrà a chiamare il medico per tentare l’ultimo salvataggio del padre ma Kate, bloccata in un sacrificale dissolvimento di spasimi e smanie, chiederà al figlio di dimenticare e agli altri di fare silenzio.
Il non-detto resterà, da questo dramma di Arthur Miller, un caposaldo della drammaturgia realistica, tipicamente americana e non solo, un crocevia necessario per far palpitare sulla scena il teorema di una verità spesso inattingibile. Diventerà nella poetica e nel repertorio dei drammaturghi quel linguaggio teatrale che coniuga tanto la teatralità di una menzogna quanto la drammaticità di una verità negletta, in un ambito che resta seducente e quasi sempre temerario per chi scrive della realtà.
__________________________
Si racconta che una pregevole edizione televisiva (sicuramente perduta) di questo dramma fu quella con Mario Carotenuto nella parte di Joe Keller. Attore caratterista della commedia all’italiana, anche talora casereccia, Mario Carotenuto diede di sé grandi prove drammatiche nelle parti di Shylock da “Il Mercante di Venezia” di Shakespeare e di Peachum nella brechtiana “Opera da tre soldi”. Di recente “Erano tutti miei figli” è stato rappresentato dalla compagnia di Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini.
__________________________
***
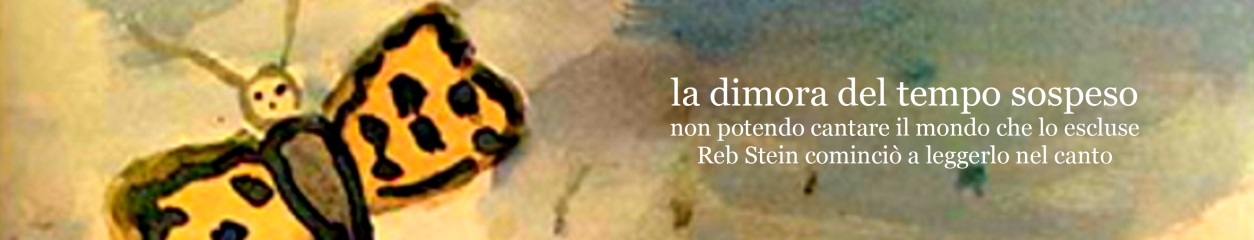



Ringrazio Antonio Scavone per la sua ricostruzione impeccabile e coinvolgente dell’incontro tra “teatralità della menzogna” e “drammaticità delle verità neglette” in “All my sons” di Arthur Miller.