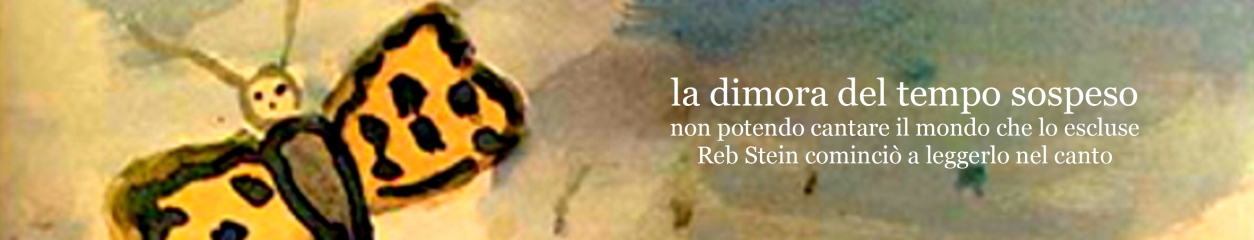[Tratto da Tash-Blog del 10 e 14 dicembre 2006]
Niente paradiso per nessuno
Ciclicamente ridanno in tv Gli ammutinati del Bounty, di Lewis Milestone, del 1962.
Delle tre narrazioni cinematografiche della storia che conosco (L’ammutinamento del Bounty di Frank Lloyd, 1935 e The Bounty, di Roger Donaldson, 1984) tutte a mio parere ottime, questa è quella che preferisco.
Non perché sia la migliore, ma perché quando la vidi la prima volta avevo diciassette anni e colpì la mia immaginazione in modo indelebile.
Da allora sono ritornato più volte sul tema Bounty, approfondendolo un poco.
Si tratta di una delle vicende più appassionanti e per certi versi incredibili di cui abbia mai avuto notizia.
Lo Spate, nella sua magnifica Storia del pacifico in tre volumi, Einaudi 1987, sostiene che al 1979, data della prima edizione dell’opera, la bibliografia sull’Ammutinamento contava 800 titoli.
La vicenda è notissima e ha numerosissimi risvolti significativi: non mi ci dilungo.
Rammento solo che i fatti si svolsero nel 1789, come se la Rivoluzione avesse trovato modo di manifestarsi anche in Gran Bretagna, ma in forma molto ristretta e dall’altra parte del globo. Evidentemente un po’ ovunque i tempi erano maturi, come dicono gli storici.
Devo fare una dichiarazione preliminare: io sono un ammutinato del Bounty.
Voglio dire che ogni volta che vedo uno dei film citati, mi identifico con un ammutinato del Bounty.
Ma non con il capo della rivolta, il primo ufficiale Fletcher Christian, che mi sta un po’ sul cazzo anche se ne comprendo il rovello – sto parlando del Christian del film, modellato dal narcisismo attoriale di Marlon Brando, più che di quello vero, figura molto controversa e per certi versi misteriosa – mi identifico invece con uno qualsiasi dei marinai semplici che presero la nave, metti con Mills (nel film di Milestone è Richard Harris) o con Mc Coy o qualsiasi altro.
Insomma con uno di quelli che si rivoltarono, non tanto contro le angherie di Bligh, ma per cominciare una nuova esistenza come esseri umani pienamente liberi, padroni di sé e del proprio destino, decidendo di finire il loro giorni nell’Emisfero d’acqua, piuttosto che condurre un’esistenza di terra o di mare come forza lavoro sotto-messa, se gli andava bene, o in qualche prigione del regno o sulla forca, se gli andava male.
È di una decina d’anni dopo, del 1788, la prima deportazione di galeotti nel nuovo Galles del Sud del quale diventò governatore proprio William Bligh (vedi lo splendido La riva fatale di Robert Hugues, Adelphi 1990) e dove dovette affrontare un nuovo ammutinamento, stavolta da parte di gente di terra.
Bligh, che dopo i fatti del Bounty non cadde affatto in disgrazia e nel 1801 aveva preso parte con Nelson alla battaglia di Copenaghen, era di una tempra mostruosamente dura e accorta, tipica di coloro cui fu affidato il compito di costruire materialmente l’impero britannico: buttato dagli ammutinati in una scialuppa piena di uomini, con quella navigò per 5.000 miglia nell’Oceano Pacifico, senza perdere neanche un uomo, a parte un poveraccio che fu ucciso dagli indigeni dell’isola di Tofoa, primo ed unico approdo della lancia in tutto il tragitto fino a Timor.
Christian avrebbe dovuto ucciderlo, ma non lo fece.
Non sapeva che una rivoluzione in cammino non ha (non deve avere) pietà per nessuno.
Ancora oggi durante le scene cruciali del film in cui gli ammutinati prendono la nave, mi sorprendo a incitarlo: ammazzalo!
Sulla natura dei rapporti tra Christian e Bligh si è detto di tutto, compresa l’ipotesi che si sia trattato di un conflitto tra omosessuali latenti, o cose del genere.
Christian è sovente descritto come uno psico-labile, un caratteriale facile alla prostrazione, capace di covare ire furibonde, eccetera.
All’epoca Bligh aveva poco più di trentacinque anni (Christian ne aveva 23), quindi non era il vecchio descritto in tutti i film, ma un marinaio nel fiore dell’età.
Ottimi in proposito i diari di Bligh e i documenti del processo (Il viaggio e l’ammutinamento del Bounty, 1787-1790, a cura di F. Marenco, Longanesi 1969).
Dimenticavo un particolare importante per farsi anche una vaga idea di ciò a cui si era temprato Bligh: prima del viaggio del Bounty aveva partecipato come ufficiale al terzo viaggio di James Cook, quello che si concluse con l’uccisione del capitano alle isole Hawaii. Quindi aveva già fatto il giro del mondo a vela, conosceva il Pacifico, sapeva navigarlo ed era già stato a Tahiti.
Sono convinto che fu l’isola di Tahiti il motore della rivolta e la vera protagonista della vicenda.
Voglio dire che se la causa prima fu la durezza di Bligh e le condizioni in cui erano costretti a vivere i marinai dell’epoca, lo scopo vero dell’ammutinamento era tornare a Tahiti e vivere per sempre in quello che allora sembrava, e probabilmente era, il Paradiso Terrestre.
L’impatto della gente del Bounty col mondo come sarebbe potuto essere e non era stato, l’ipotesi apertasi all’improvviso di una vita diversa, non sotto-messa a nessun potere e felice, l’estasi di una natura che appariva benevola e generosa, il clima primaverile, il mare pieno di pesci, il cibo che sembrava pendere dagli alberi.
E poi, cosa più importante, la disponibilità carnale delle tahitiane (sull’isola la gente di Cook aveva diffuso la sifilide, lo stesso Christian pare ne fosse affetto, come la maggior parte dell’equipaggio del Bounty: come dire che Dio non si dimentica mai di noi), l’assenza del concetto di peccato legato ad un atto sessuale, la famiglia aperta, eccetera.
Naturalmente le società oceaniche erano un inferno di taboo (meglio scrivere “taboo”, è più paccuto), tra i quali non c’era però quello sessuale.
Per esempio: alle Hawaii l’intrico di proibizioni era diventato tale che nel 1819 il re Kamehameha II le abolì in blocco, assieme a tutta la religione dei padri (Susanna Moore, Il mito delle Hawaii, Feltrinelli 2004).
La crudeltà di Bligh accentua la percezione di tutto questo, la rende insostenibile: Bligh è ciò che li attende per il resto dei loro giorni, Tahiti è una finestra inaspettata nel continuum della vita da servi che li aspetta, stabilita per loro sin dalla nascita, è una finestra spalancata su un mondo di possibile libertà, anche dal bisogno.
L’isola deserta di Pitcairn dove gli ammutinati finirono i loro giorni era invece un minuscolo scoglio abbastanza desolato, povero di risorse, privo di approdi, relegato in un tratto completamente vuoto di Oceano Pacifico.
Eppure l’Arcangelo l’aveva detto a chiare lettere: niente più Paradiso per nessuno.
A Pitcairn gli ammutinati si scontrarono ferocemente e ripetutamente tra loro, probabilmente per il possesso delle donne e delle poche risorse disponibili.
Ben presto gli indigeni che li avevano accompagnati da Tahiti si rivoltarono per il pessimo trattamento cui erano sottoposti e nel 1794 uccisero un buon numero di bianchi, tra cui Fletcher Christian.
Il mondo autoritario, razzista e classista in cui erano nati e cresciuti quegli uomini si era installato nelle loro menti al punto da vanificare la realizzazione di ogni possibile frammento di utopia.
Neanche la Rivoluzione in formato ridotto del Bounty riuscì a costruire una micro-società nuova, producendo alla lunga la solita merda che tutti ben conosciamo.
Quando nel 1808, dopo quasi vent’anni, furono trovati per caso da una baleniera americana, ne era rimasto solo uno, Adams, più un certo numero di donne e bambini.
Ma cosa sia successo in quei vent’anni non si è mai saputo con certezza.
***
Era meglio uccidere il capitano Bligh
Christian non uccide Bligh.
Questo è il punto.
Il dato è storico, come pure è storico il fatto che gli lasciò portare con sé carte nautiche e sestante, acqua e viveri, come se non sapesse che quello era probabilmente in assoluto uno dei più esperti navigatori esistenti all’epoca.
Christian non se la sente di tradire completamente la propria classe di appartenenza, non se la sente di profanare e negare e azzerare del tutto il ruolo sacrale di Bligh: il comandante di una nave a quel tempo era dio in terra, era un intoccabile.
Christian odia e disprezza Bligh con tutte le sue forze, l’uomo e il suo agire gli danno il voltastomaco, tuttavia rispetta l’aura super-umana che competeva ad ogni comandante e dalla quale, in fin dei conti, anche lui trae il suo potere sulla nave.
Christian non riesce a mettersi completamente, cioè con piena convinzione di mente e di cuore, dalla parte degli oppressi, cioè della ciurma.
Anche lui, in cuor suo, disprezza quei volgari proletari del mare: vuole solo che siano trattati (dominati) umanamente, nel pieno rispetto della loro dignità di uomini.
Christian (il Christian-Brando del film, naturalmente) crede nella persuasione, perciò disapprova il regime di terrore instaurato da Bligh: lui è un dandy e i dandies non cadono mai di stile, in nessuna circostanza e con nessuno.
Ma le rivoluzioni, anche quelle di piccolo formato, se sono tali, cioè se investono dinamiche etico politiche della stessa natura, vale a dire inerenti la presa del potere tramite coercizione fisica e violenza sull’avversario, comportano sempre cadute di stile.
Anzi.
Penso di potermi spingere oltre e dire che il rivoluzionario di professione possiede molte caratteristiche del dandy, come la non curanza di sé, il gusto per la dissipazione, l’interesse ai procedimenti di auto-negazione, per il mescolarsi cool col mare della storia, dei processi vitali e di ribellione, l’attenzione per l’etica e l’estetica del gesto, eccetera.
Forse la vera differenza sta nel fatto che il vero dandy non crede a nulla e agisce solo perchè altrimenti si annoierebbe.
Dunque il dandy si mette dalla parte degli oppressi, non perché creda nella possibilità di un loro effettivo riscatto, ma perché gli sembra la parte migliore con cui stare, in quanto la più decente.
E soprattutto perché gli appare un atto maggiormente contro-intuitivo del mettersi dalla parte del più forte, come gli sarebbe più agevole e naturale fare.
La colpa e la tragedia del primo ufficiale del Bounty consistono in questo rimanere a metà strada, nel non riuscire a scegliere davvero tra oppressi e oppressori per poi condividerne fino in fondo sorte e ruolo.
Lenin, che sarebbe nato solo nel 1870, avrebbe saputo descrivere molto bene e con parole taglienti il ruolo “socialdemocratico” di Christian nella vicenda del Bounty: la sua propensione per la partecipazione invece che per la rivoluzione, per la via democratica invece della presa del potere, inevitabilmente violenta, degli oppressi.
E poi il compito di Fletcher Christian non si sarebbe dovuto limitare alla presa del Bounty.
Sarebbe dovuto andare molto oltre e guidare la costruzione della comunità di Pitcairn secondo criteri non solo di equità sociale, ma addirittura comunitari e utopici: da ciascuno secondo le sua capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni.
Perché no? Quale occasione migliore?
*