Il campo del vasaio
(Un incontro impossibile)
Hanno detto che passerà di qui, si fermerà senz’altro in questa locanda infima e sordida che viene aperta solo quando i romani giustiziano ladri e sobillatori politici lassù sul Calvario, quel piccolo colle che si erge poco lontano dalle mura di Gerusalemme.
Si fermerà qui, ne sono convinti l’oste e gli avventori perché tutti si fermano a spendere il premio vinto con le scommesse sui condannati – chi muore prima degli altri – oppure per affogare nel vino la stizza di aver perso soldi sicuri nell’incerta sfida con la sorte o il destino.
“Vedrai, straniero, che si fermerà per spendere una buona parte della sua fortuna”. “Fortuna? – blatera un carovaniere di Betania – Il prezzo del suo coraggio, semmai!”. Non solo l’oste ma anche i suoi clienti avvinazzati sembrano conoscere gli avvenimenti prima del tempo: sapevano quello che era successo nella trattativa con le autorità religiose capeggiate da Caifa, sapevano che cosa sarebbe poi accaduto nell’orto di Getsemani, le responsabilità scaricate dai sacerdoti ai romani e da questi ai giudei, il processo-farsa del Nazareno, la neutralità del governatore Pilato, la sentenza delegata al popolo, la liberazione di Barabba, il supplizio della via crucis, dei chiodi, della lancia che trafigge il costato…
E con un candore molto ben recitato chiedo: “E poi?”.
– Poi… Come se non si sapesse!
L’oste scuote la testa, mi versa del vino nel boccale e guarda fuori, al cielo che improvvisamente si oscura.
– Poi dovrà decidere cosa fare del denaro avuto. E verrà qui per deciderlo.
Un fariseo, commerciante di velli di pecora, afferma che doveva andare così: “Era scritto!”. “Era scritto dove?” aggiungo con sarcasmo per non dargli il tempo di pensare e lui, non senza difficoltà, se ne esce con un carognesco “Se non lo sapete voialtri che raccontate i fatti, chi mai dovrebbe saperlo?!” e, infuriandosi, casca giù dallo sgabello versandosi il vino sul volto e sulle vesti. Gli altri avventori non condividono la sortita del fariseo ma lasciano capire che le cose, in qualche modo, erano state profetizzate proprio da coloro che adesso ne lamentano le conseguenze.
– Volete dire che le aveva previste il Nazareno?! Per forza! Non è forse un profeta?!
– Lui dice di più, dice di essere il Messia.
– E allora: se era tutto scritto perché vi sconcertate?
– Straniero, tu vieni dalla terra di Roma e non puoi capire: quello che è scritto si avvera, quello che deve avverarsi è già manifesto nelle parole dei Profeti.
– Sarebbe a dire?
Ma non c’è risposta. Stupefacente che un oste giudeo abbia tirato fuori una massima chiara e oscura che sarebbe propria di un sacerdote ma, evidentemente, qui in Asia Minore, il pensiero e la parola si intrecciano e si compensano, tanto nella rivelazione quanto nel mistero.
Avvertiamo lamenti e implorazioni che arrivano su dal colle: le crocifissioni sono state eseguite e l’ultima, quella che ha radunato una folla di fedeli e curiosi, si è compiuta in un silenzio innaturale, sotto un cielo annerito da una nuvolaglia sortita dal nulla e un vento scontroso che fa vibrare gli alberi sparuti di un campo abbandonato. C’è silenzio anche nella locanda e anche i volti si oscurano, le ombre primeggiano e solo un debole fascio di luce taglia, come nelle tele di Caravaggio, le figure e le cose, come se volesse farle palpitare nella fissità del gesto e della postura.
L’atmosfera, si sarà capito, è opprimente: i boccali non fanno rumore quando vengono lasciati sui tavoli, gli sgabelli non stridono, non frusciano neppure le tuniche e i mantelli, non cigolano i cardini della porta sbattuta dall’impeto capriccioso del vento. Molti di noi si affacciano alla finestra della locanda per guardare quello che sta succedendo sul Calvario davanti alle tre croci: un gruppo di persone è ancora lì come per testimoniare un sentimento di pietà ma molti di loro, gli uomini soprattutto, sembrano incerti e innervositi, sopraffatti da un senso di impotenza o forse dal rammarico.
“Chi sono quegli uomini… – chiedo all’oste – I discepoli del Nazareno? Quelli che saranno chiamati apostoli?”.
Gli avventori si guardano e non replicano: la mia domanda li ha infastiditi più che sorpresi e dovranno giudicare la mia curiosità come una questione inopportuna, da lasciar perdere sul nasce-re prima che diventi una petulante e capziosa ossessione. Sì, forse ho esagerato a spiattellare come dicerìe quel che risulterà dai testi sacri, a confondere fede e coscienza o dati storici con le notizie e i racconti accreditati dai Vangeli e tuttavia, per reggere questo complesso sistema di verità e leggenda, non posso fare a meno di sollecitare dai testimoni del tempo le emozioni e le opinioni suscitate da uno dei più grandi avvenimenti nella storia dell’umanità: l’uccisione e la morte del Nazareno.
La verità è che mi trovo in un tempo e in un posto che non sono miei, sbalzato dalla fascinazione di un racconto in una circostanza emozionale che scatena tanto una temeraria empatia quanto un’ineffabile percezione di estraneità. Se è vero quello che ha preannunciato l’oste, tra poco, in questa lercia locanda ai piedi del Calvario, entrerà l’uomo che sarà giudicato nei secoli nient’altro che un reprobo ma che avrà anche il plauso e l’approvazione di buona parte dei suoi contemporanei per il coraggio dimostrato, come ha sostenuto il carovaniere di Betania.
Prepararsi a un incontro con una personalità famosa o celebre non è mai facile, solo gli sprovveduti e i faccendieri riescono nell’impresa di stabilire un rapporto di confidenza, se non di complicità, con i “personaggi” universalmente riconosciuti degni di onori e di gloria. Un incontro con personalità sfuggenti, invece, con persone indecifrabili per il tratto caratteriale o per la loro storia individuale giudicata dai più controversa, può ridursi ad un esercizio di maniera, ad un’intervista salottiera per magnificare la stupidità o il servile ossequio dell’intervistatore e l’impenetrabile ieraticità dell’intervistato. Non bisogna cadere in questo ulteriore inganno: fidandomi degli appunti presi sull’uomo che dovrebbe entrare in questa locanda, mi assumo l’incarico di essere distaccato ed equanime, di far emergere da questo incontro qualcosa che sia più vicino alla verità e più lontano dalla supponenza.
“Straniero, – mi dice l’oste – sta arrivando”. Il momento si presenta, l’attesa si compie: entra nella locanda Giuda Iscariota, il traditore di Gesù Cristo.
La prima sorpresa è data dalle sembianze e dalla figura di Giuda: me l’aspettavo basso e tarchiato, come lo dipinse Giotto nell’affresco “Il bacio di Giuda” alla Cappella degli Scrovegni o come lo rappresentò Pasolini nel “Vangelo secondo Matteo” (il nerboruto Otello Sestili) e invece mi ritrovo davanti un uomo alto, aitante, con i tratti del volto gentili, la pelle chiara, lo sguardo cupo, l’animo in sussulto frenato da un’ansia incompiuta, negletta. L’altra sorpresa sono i capelli di Giuda: sono rossicci, di un colore che sembra falso e posticcio, come le parrucche di stoppa delle bambole.
Giuda si siede a un tavolo e viene subito servito dall’oste che gli versa nel boccale lo stesso vino profumato che abbiamo bevuto nell’attesa: Giuda tracanna il suo vino e, come guardando il vuoto attorno a sé, fa capire all’oste di riempirgli di nuovo il boccale ma stavolta non beve. Direi che è assorto nei suoi pensieri: non muove un muscolo, non accenna a un gesto e i suoi occhi sono ancora bloccati in quello sguardo tetro e inespressivo. L’oste mi fa un segno, per invogliarmi a parlare, ma confesso che non sono ancora pronto a iniziare un colloquio con l’uomo dai capelli rossi, l’uomo che da poco ha visto agonizzante sulla croce il suo maestro. La mia esitazione viene risollevata dall’oste che si rivolge con cautela a Giuda. “Fratello, questo straniero vuole conversare con te”.
Dopo un silenzio che sembrava ostile, Giuda chiede a sua volta: “A quale scopo vuole conversare con me?”. Neanche adesso ha rivolto uno sguardo a noialtri che gli stiamo intorno: il carovaniere di Betania e il commerciante fariseo mi spronano a farmi avanti, a dare inizio a questa conversazione.
Non posso più tirarmi indietro e non posso perdere, d’altra parte, quest’opportunità che mi sono, sia pur fittiziamente, creata: mi alzo, sposto lo sgabello vicino al suo tavolo, mi siedo e comincio con la più semplice delle domande.
– Rabbi, non c’è nessuna spiegazione sul tuo nome. Come mai?
Adesso Giuda mi guarda, ha alzato gli occhi su di me, mi ha squadrato e mi ha chiesto: “Da dove vieni, straniero?”.
– Dal mare di Occidente.
– Sei greco o romano?
– Vengo da quella che fu chiamata Magna Grecia.
– Perché dici che il mio nome non ha spiegazione? Sono Giuda di Simone.
– Ma sei conosciuto come Giuda Iscariota.
– E allora?
– Non c’è nessuna tribù che si chiami “iscariota” o che annoveri gli “iscarioti”. Probabilmente è un nome inventato o un soprannome.
– Se è inventato avrà il suo significato e se è un soprannome avrà pure un senso.
– Ma perché voi giudei non arrivate mai a una conclusione quando vi esprimete? Perché girate sempre oziosamente intorno agli argomenti senza mai definirli se non rinominandoli ogni volta daccapo? Non credi che, parlando così, scadiamo nel luogo comune, nell’ovvietà?
– Tu parli con intenzioni nascoste, straniero. Sai molto di più di quello che chiedi eppure lo domandi: non è anche questa, ovvietà?
Inevitabilmente è arduo interloquire con un giudeo, specie quando riveste un ruolo politico più che religioso: sono abili, come tutti i levantini, a capovolgere e dirottare questioni e intenti con la più sofisticata delle argomentazioni. Parlano come se dovessero fare solo quello, come se fossero nati solo per parlare o lusingare o aizzare, comunque per rendere un confronto piatto e inconcludente e riservarsi poi una replica acuta e inattaccabile. Mi trovo nella terra dell’ovvietà, dell’evento che si fa logos e del logos che contempla gli avvenimenti preventivati dai Profeti: in una terra che, a quel tempo, cercava la sacralità della sua immutabilità. Costretto a tergiversare, tergiverso.
– D’accordo. Sul Calvario si è consumato un evento epocale: il tuo maestro è stato crocifisso.
– Il mio maestro aveva deciso il corso della sua vita e anche della mia.
Decido di affrontare senza mezzi termini la ragione e lo scopo di quest’incontro e gli chiedo guardandolo negli occhi: “Perché hai tradito Gesù?”.
Come le pecore si radunano a un cenno di richiamo del pastore e gli si avvicinano in fretta sicure di essere ricondotte all’ovile per ripararsi dal freddo della notte, così l’oste, il carovaniere, il fariseo e gli altri avventori ci circondano in un silenzio rispettoso, disponendosi intorno a noi con sollecitudine, convinti di poter assistere alla rivelazione di un segreto e di poterne fruire con discrezione il messaggio. La mia domanda ha sortito questo effetto negli avventori ma non ha creato la stessa fiducia nell’uomo dai capelli rossi: il suo sguardo s’è intriso di sospetto, le sopracciglia si inarcano e i suoi occhi mi guardano con un freddo malanimo, come se volessero trafiggere i miei e rendermi cieco ad una gelida invettiva che tarda però a compiersi.
Comincia a piovere senza che ci siano stati tuoni o lampi ma nessuno di noi s’è distratto, nessuno di noi ha guardato fuori, su al Calvario, dove le tre croci si stagliano scure e tremolanti sotto lo scroscio dell’acqua, lasciando indistinti i corpi dei tre crocifissi.
La pioggia, però, ha fatto cambiare atteggiamento a Giuda: si è liberato dall’angustia che lo aveva suggestionato, si è quasi rinfrancato, sorretto da una suadente consapevolezza che gli ha mutato l’umore, rinfrescandone la smania di dire finalmente la sua verità.
“Ho tradito il mio maestro perché lui me l’aveva chiesto, perché questo era il suo intendimento e il suo fine. Volevo che si spezzasse quella missione che lui aveva scelto di compiere ma che non trovava mai la sua conclusione, girando sempre a vuoto sulle sue stesse parole come gira a vuoto l’asino intorno alla macina del mulino, tornando sempre al punto dal quale è partito per non raggiungere mai un punto di arrivo, non avanzando mai oltre se stesso…”.
Gli avventori mi guardano deplorandomi, come per rammentarmi l’arbitrio irriverente col quale ho affrontato uno dei dodici discepoli del Nazareno ma non mi lascio fuorviare dalla loro solidarietà di parte e rincaro la dose di impudenza con una domanda antipatica: “Vuoi dirmi che gli hai fatto un favore tradendolo?!”.
La reazione di Giuda è fulminea: gli occhi si arrossano, ridiventano spade pronte a saettare e la mano si leva nell’aria per empiti di collera e sdegno. La mia replica è serafica: “Non temo la tua ira, rabbi, e non l’asseconderò con accuse fantasiose e futili infingimenti. Non hai risposto alla mia domanda e sarebbe opportuno che tu lo facessi e non solo per me”.
Giuda si placa, lascia planare sul tavolo la mano che aveva sollevato minacciosa e si avviluppa nel suo mantello per abbracciare se stesso, sentire il suo corpo unito al suo animo, trasmettere dall’uno all’altro la medesima risolutezza, forse addirittura un segnale di benessere. E comincia a parlare, come parlano i giudei, gli orientali: con parafrasi, metafore, similitudini, con il repertorio evocativo e fideistico di coloro che hanno dedicato la propria esistenza all’epifania di un’idea, con l’idea che anche la loro vita – vissuta o negata – fa parte di quel progetto.
“In quello che già alcuni chiamano il ‘Vecchio testamento’ l’uomo era concepito e designato come figlio di Dio. La genesi dell’uomo, le sue azioni, le sue aspirazioni erano tutte regolate dalle leggi di Mosè, dai princìpi della Santa Alleanza e dai vaticinii dei Profeti Maggiori ma l’uomo ha tribolato perché non riusciva a cogliere il confine tra Dio e la terra, tra ciò che è e ciò che deve essere e la stessa ‘Terra promessa’ si rivelava come una grande radura incolta nella quale si poteva spargere un seme ma era dif-ficile raccoglierne un frutto. Iahvè era l’agronomo di quel terreno sconfinato ma restava lontano, come un genitore incollerito, e il figlio di Dio non era in grado di abbracciarlo come un padre com-prensivo e di riconoscerlo come tale.”.
È evidente che Giuda stia compiendo una ricognizione a ritroso sulla sua storia e la storia del suo popolo, alla ricerca di ragioni e motivazioni per tutto ciò che è stata – e per tutto ciò che ha sconvolto – la presenza del Nazareno nella terra di Giudea e farebbe pensare, questa prolusione retrospettiva, a un tentativo tardivo e insincero di autogiustificazione. Giuda traccia il percorso del suo maestro perché ha smarrito il suo di percorso? Conviene chiederglielo.
– Rabbi, che cosa ti ha disorientato nella parola del tuo maestro? Forse già coltivavi dubbi e incertezze sulla storia del tuo popolo, la storia religiosa dico?
– Un popolo non ha una storia religiosa, un popolo è religioso e costruisce la sua storia tra mille travagli e spesso non approda a niente che sia illuminante.
– Quindi, secondo te, neppure il Nazareno ha riscattato il tuo popolo dai misteri di quello che sarà chiamato, e che noi chiamiamo già, ‘Vecchio testamento’?
– Gesù ha detto di essere il Figlio dell’Uomo, il figlio di Dio che si è fatto carne: ha aggiunto un altro mistero ai tanti segreti che ci portiamo nell’animo e che ci fanno vivere.
– Era questo che non condividevi nella parola del tuo maestro? La doppia o tripla identità che dichiarava di incarnare?
– Nella storia dello spirito non ci sono parole da condividere ma leggi e regole, profezie e traguardi, scopi e necessità. Quando lui ha parlato del Regno dei Cieli, di un regno che sarebbe già nostro se solo fossimo capaci di volerlo, aveva già infranto la nostra storia e consegnato alla Giudea una nuova storia di cui non sapevamo nulla ma che ci attraeva perché ci spaventava.
È un uomo sconfitto, Giuda, o uno sprovveduto in balìa di atti e fatti più grandi di lui? Gli dico di non aver compreso il suo timore per la nuova storia o nuova alleanza che Gesù aveva proposto e designato per la terra d’Israele. Fa qualche passo, guarda su al colle e poi riprende a parlare.
– Il Maestro ha detto di essere stato mandato dal Padre suo non per portare la pace ma la spada. Ne eravamo già consapevoli dal profeta Isaia e da Giovanni detto il Battista ma Gesù ha distinto ogni consuetudine, separato il figlio dal padre e il fratello dal fratello, insegnandoci a ritenerci uguali ai nostri simili, a rispettare per essere rispettati, a non confondere quel che si deve a Cesare e quel che si deve a Dio. Ci ha insegnato a distinguere ciò che vediamo e facciamo giorno per giorno e ciò che lui vedeva e faceva al di là di ogni singolo giorno. Non era facile per noi assimilare i suoi princìpi e le sue regole, come non era facile conferire alle sue prerogative il crisma della divinità. Gesù si dichiarò figlio di Dio venuto sulla terra come uomo e come uomo doveva compiere la sua breve avventura dalla nascita alla morte e poi a una nuova vita per dimostrare la sua natura e la sua missione.
– Che cosa non ti ha convinto, di questa missione di Cristo?
– Noi siamo un popolo che viene da Abramo, da Mosè, da Salomone e anche da Erode e Caifa. I sapienti ci hanno sempre detto di dover aspettare Emmanuel il Salvatore ma non come ci saremmo salvati.
– Rabbi, permettimi…
– Perché continui a chiamarmi ‘rabbi’? Non è un titolo che mi appartiene, appartiene solo a Gesù.
– Come desideri, Giuda: non ti chiamerò ‘rabbi’. Ti voglio parlare di quello che la tua figura, il tuo gesto, l’avventura della tua vita di discepolo, sia pure per un tempo brevissimo, hanno ispirato nei secoli studiosi, artisti e finanche filosofi.
– Immagino cosa abbiano detto di me: tutto il male possibile.
– Non ci crederai ma non è così. Sei stato visto come un intellettuale critico e progressista, per esempio in un film famoso di Norman Jewison tratto dall’opera rock “Jesus Christ Superstar” di Lloyd Webber-Rice. Oppure sei stato raffigurato come un uomo incerto, fragile, vittima di un destino atroce e immodificabile. Hanno scritto di te autori come Borges, sono state create associazioni in tuo onore. Nei secoli, negli anni il “personaggio” Giuda è stato maltrattato e vilipeso ma negli ultimi tempi sei stato rivalutato: persino l’attuale Pontefice di Roma ha parlato di te come di un fratello.
– Un fratello inaffidabile, suppongo.
– No, un fratello e basta. Su di te e su quello che hai fatto si sono accaniti saggisti e teologi o, come diciamo oggi, opinion makers e quello che risulta tuttora lampante e ingiustificato, quello che fa ancora discutere, è il tuo tradimento.
– Fu il Maestro a dire che uno di noi l’avrebbe tradito e quando gli chiesi se fossi io…
– …Lui ti rispose: “Tu l’hai detto”.
– Sì, così. Anche Simone, quello che Gesù rinominò Pietro, lo rinnegò e anche a Simon Pietro Gesù l’aveva profetizzato. Come vedi, straniero, il nostro maestro aveva già prefigurato gli avvenimenti prima che accadessero e aveva assegnato a taluni di noi i comportamenti che li avrebbero poi contraddistinti. – Tutto ciò che significato ha avuto?
– Ha avuto il significato di una lacerazione improvvisa, co-me quella di una crepa nel muro di una casa quando la terra trema: il muro non si sfalda, la casa non crolla ma quella fessura resta come un’avvisaglia, come un monito.
– Come un dubbio?
– La verità è che Gesù ci aveva scelti senza che avessimo una particolare predisposizione a intenderne gli insegnamenti e soprattutto a praticarne l’applicazione. Eravamo sinceri e genuini, nudi nella nostra franchezza e ricchi della nostra insensatezza.
“Come uno di noi!” sbotta compiaciuto il commerciante fariseo ma Giuda spegne subito quell’ardore velenoso e ruffiano. “Tu eri tra i mercanti cacciati dal tempio e non ci sarà più un luogo sacro che potrà ascoltare la tua lingua di serpente, se non accostandola alle fiamme di una fornace”. Il fariseo non può che tacersi e restare interdetto, non riuscendo neppure a bere dal suo boccale. Interviene allora il carovaniere di Betania, uomo rude e avvezzo ai battibecchi senza fronzoli: “Ma ora che il vostro maestro è finito, cosa ne sarà di voi? Come riuscirete a continuare la sua opera se non l’avete intieramente capita?”. Sembra di stare in un libro di Elias Canetti.
Giuda si avvicina alla finestra della locanda, guarda le tre croci sul Calvario e poi dice che non tutti la continueranno ugualmente, quell’opera: “Ci sarà chi ne scriverà, chi ne costruirà le fondamenta, chi ne insegnerà le virtù e i doveri e chi ne morrà per difenderla o liberarsene”.
Non oso replicare, vorrei dire per il rispetto della storia e della sua storia. Giuda si gira verso di noi, verso di me e dice indicando: “Laggiù c’è un campo, straniero: con pochi alberi, rinsecchiti e malati, che non hanno prodotto frutti. Gesù ci aveva ammoniti di tagliare e bruciare gli alberi inerti ma in quel campo nessuno mai è intervenuto a sanare quella terra e i semi che potevano allignare”.
– Il campo del vasaio, così lo chiamano.
– Ma avrà un altro nome nel tempo avvenire.
– Conosco l’altro nome: Aceldama.
– Infatti.
– Ma quella degli alberi inerti era una metafora: il tuo mae-stro alludeva ai propositi che non portano a conclusioni edificanti.
– Gli alberi infruttuosi restano tali, sia che si parli della loro natura, sia che si alluda ad altri significati, che essi comunque sollecitano. Cosa credi di trovare accanto a un albero senza linfa? Le zolle della terra saranno aride e nessun germoglio fiorirà: anche gli insetti usciranno dalle loro tane per diventare subito preda di famelici uccelli notturni.
– Un quadro desolato stai dipingendo.
– Come le parole che lo descrivono e gli uomini che lo renderanno tristemente o inutilmente memorabile.
– Permettimi una domanda estemporanea, tipica dei nostri salotti televisivi. Perché ci fu bisogno di quel bacio per indicare Gesù nell’orto di Getsemani? Perché il segno del tuo tradimento fu un bacio? Gesù era riconoscibilissimo, era unico tra di voi che gli stavate attorno. Non ti è sembrata una trovata spettacolare, quel bacio?
Giuda risponde esitando: “Mi fu chiesto di indicarlo a quel modo…”. Insisto: “Strano… Avevi accusato Gesù di aver permesso a una prostituta di ungergli i capelli con un balsamo e poi tu ti rendi artefice di una manovra odiosa, con l’artificio avvilente di un ingannevole bacio”. Giuda non risponde, resta immobile, forse colpito dal tormento, da una resipiscenza tardiva.
– Come giustificasti quel gesto col Maestro?
– Non ci fu bisogno di giustificarlo perché fu Gesù a chiedermi di fare in fretta quel che dovevo fare.
– Ma per te stesso, dico, non per i sacerdoti del Sinedrio, fu un commiato, un addio, una supplica, una confessione di slealtà, una richiesta di perdono?
– Quante parole usi per indicarne una sola: fu l’esecuzione di un ordine del Sinedrio, del Maestro e della mia sorte.
– Ma se non ci fosse stato quel bacio, se non ci fosse stato il tuo tradimento, cosa ne sarebbe stato di Gesù?
Giuda non risponde subito: i suoi occhi, fissi in uno sguardo estatico, rincorrono pensieri già meditati e tutta la sua persona mostra un abbandono, un distacco che ce lo rappresenta davvero lontano e reticente. Interviene l’oste che se n’era stato zitto vorrei dire per devozione: “L’ha già detto cosa succederà e noi lo sapevamo, l’abbiamo sempre saputo”. Il carovaniere di Betania aggiunge che non sarebbe cambiato nulla perché così doveva accadere, perché era scritto che accadesse comunque. Il fariseo non se la sente di commentare e si limita ad annuire.
“Quello che voi pensate – replica infine Giuda – sugli esiti negativi e probabili della mia condotta è come un filo d’erba scampato alla devastazione di un campo bruciato. Non ha senso e riguardo come non ha significato e decoro ciò che mi è stato imposto di fare. Non ci sarà perdono perché io stesso, per primo, non lo chiedo, lo eseguo”.
Nessuno parla benché abbiamo tutti intuìto cosa intenda Giuda con quelle parole: “Lo eseguo”. L’oste si siede, sopraffatto dallo sconcerto, manifestando così quel suo sentirsi inadeguato come uomo e come taverniere della locanda dei supplizi, dove si beve e si scommette sui condannati, giudicando da un pulpito sacrilego, morboso come un palco d’opera. Il carovaniere di Betania china il capo, sussurra qualcosa ma non aggiunge altro a quei fiati che non ce la fanno a diventare parole. Il fariseo giocherella col suo boccale, poi smette e afferra e stringe la sua scarsella di monete, l’unica prova della sua idea di realtà.
Giuda si rivolge a me che continuavo a fissarlo aspettandomi una risposta esauriente o una conferma illuminante su quello che già so e che solo adesso ho potuto percepire, per così dire, “dal vivo”.
– Nel linguaggio degli zeloti “iscariota” vuol dire “sicario”: un discepolo sicario, ti sembra giusto, straniero? Sarebbe un inganno, una frode… oppure un sicario come strumento della volontà divina?
– Davvero ci credi alla volontà divina?
– Tutti noi ci aspettiamo la volontà divina per qualunque forma scelga di appalesarsi. Siamo nella terra d’Israele, nella terra dei Profeti, della carne e dello spirito. Le opere della carne le vedi anche in questa locanda: gozzoviglie, impurità, reticenze…
– E lo spirito?
– I frutti dello spirito sono amore, temperanza, lealtà… L’uomo non coglie le sue azioni, si lascia trasportare dal loro furore, si illude, si disorienta e alla fine si consegna alla negazione di tutto ciò che è stato e che poteva essere.
– Ti stai assolvendo, Giuda?
– Quando attraversi un fiume ti troverai, a metà del guado, a dover decidere: se continuare, affrontando i pericoli delle rapide per raggiungere l’altra riva oppure tornare indietro alla riva dalla quale sei partito. E tuttavia anche il percorso inverso dà sgomento. Dov’è che ti assolvi? Nel coraggio temerario o nella pavidità della rinuncia? Il nostro maestro ci ha detto di distruggere il mondo vecchio e di creare il mondo nuovo, denso purtroppo di ombre e di incertezza, come a metà di un fiume.
– Ed è a metà del fiume che ti stai arrovellando con i tuoi dubbi?
Stavolta Giuda si tace, lascia il mantello su un tavolo e si avvìa all’uscita: gli dico di fermarsi e gli rivolgo un’altra domanda.
– Sai che nessuno porterà più il tuo nome?
Giuda si ferma, non si gira e mi rassicura: “Neanche il suo porteranno e quelli che lo faranno saranno blasfemi. Ho restituito quei trenta sicli d’argento e ora devo restituire me stesso alla pace del mio ingrato nome”.
Vedo la sua sagoma muoversi, raggiungere l’uscio della locanda, i suoi capelli rossi contrastare il grigio del cielo piovoso e le figure esili del Calvario e poi sparire.
Usciamo anche noi fuori e lo vediamo inoltrarsi in quel campo di cui ci ha detto e fermarsi sotto un albero sfrondato, con un solo ramo che si allunga dal tronco come per un patibolo.
“Quello sarà il suo campo” commenta l’oste.
– Lo so.
– Non più il campo del vasaio.
– Già, il campo del sangue.
Diamo un ultimo sguardo alle tre croci poi rientriamo nella locanda: raccatto il blocco degli appunti, il portatile e comincio a uscire. L’oste mi chiede cosa scriverò di questo incontro, gli rispondo di non saperlo. Il carovaniere di Betania mi augura “Buon viaggio” e il fariseo tracanna indifferente il suo boccale di vino.
Il vespro ha cambiato colore alle cose: si vedono i primi fuochi, si sentono altre voci, giudei che si radunano e si disperdono, che ridono o inveiscono, soldati romani che piantonano soprattutto la croce centrale e laggiù, in lontananza, in quel campo brullo, si scorge un uomo che si lascia cadere da una corda legata al ramo di un albero senza frutti.
Era tutto scritto.
***
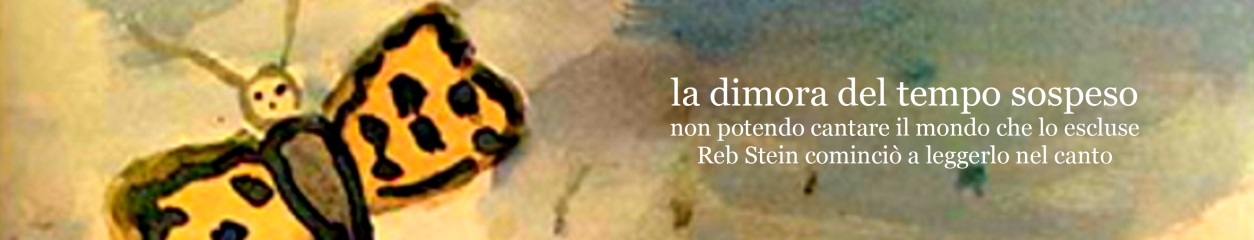

molto interessante il racconto e l’incontro con Giuda!
Comunque complimenti è ben scritto! :)
A proposito di racconti e di estate ne ho scritto uno sul nostro blog Vongole & Merluzzi
http://vongolemerluzzi.wordpress.com/2012/08/09/il-tuffo-del-granchio/
Un saluto dai Pirati ;)
Capire perchè lo scrittore Scavone, in questo testo, si rivolga al passato e, nello specifico a Giuda, bisogna forse aver compreso e metabolizzato la sua scrittura, mai banale, mai ripetitiva, anzi, riconoscibile non per le tematiche ma per l’alto stile con cui porta avanti i suoi testi.
Qui ci troviamo non solo nel Campo del vasaio, ma in un campo-racconto che ha del metafisico se lo scrittore-giornalista del nostro tempo riesce a incontrare e intervistare proprio Giuda.
Scavone ci introduce in un ambiente fisico e in una situazione storica molto lontani dall’oggi. Lo fa a modo suo, inserendo arredi e corredi al punto giusto, anzi, servendosi, laddove la storia non lo riporti, di invenzioni e metafore talmente ben descritte da sembrare reali. Così ci troviamo proprio in quell’osteria ad attendere l’arrivo di Giuda dopo che tutto si era compiuto.
Il giornalista, con le sue domande, incalza continuamente Giuda, vuole sapere il perchè del tradimento.
Giuda risponde e, tra una frase e l’altra, il giornalista ce ne descrive i gesti, le movenze, forse gli stati d’animo. Senza giudicare o condannare ci mostra semplicemente un uomo.
La sua equidistanza, non solamente temporale, dai fatti, il monte le croci il pianto delle donne, gli avventori all’interno dell’osteria, l’atmosfera a volte nebulosa, altre chiara, il fatto che le sue domande vertano sul perchè del tradimento, sono in grado di presentarci un Giuda quasi umanizzato nel senso che, pure convinto della sua azione, forse si fa venire qualche dubbio, forse si pente, forse s’impicca proprio in quel campo.
Tutto sembra normale e la distanza tra i due a volte non si avverte neanche. Il lettore sembra assistere a una rappresentazione, metafisica quanto si vuole, ma condotta con lo stile e lo spirito impareggiabile di un vero scrittore che sa rinnovarsi nei contenuti e, soprattutto, sa coinvolgere i suoi lettori e condurli proprio dove devono andare, vedere, ascoltare.
C’è una frase…Sai che nessuno porterà più il tuo nome?
che mi ha ghiacciata allo stesso modo della risposta che il giornalista dà all’oste quando gli viene chiesto che cosa avrebbe scritto sulla vicenda e lo scrittore-giornalista risponde di non saperlo.
Il fatto è che quando ti viene detto – tutto era scritto – , forse ha fatto bene lo scrittore a lasciare un bel po’ di sospeso…
Se sapessi farlo, dipingerei le ultime, credo otto o dieci righe, tanta è la meraviglia che rimandano.
E credere o non credere, in questo racconto, sembra irrilevante visto che l’intento, pur metafisico, mi è sembrato proprio questo incontro che ha dell’incredibile.
Bravo, Antonio!
questa volta sono io a ripetermi.
Un grande abbraccio a te eFrancesco
jolanda
Permettimi, Jolanda, una divagazione nella risposta al tuo commento, come sempre profondo. Tra le righe anche tu ti sei chiesta perché mai mi fossi interessato al “personaggio” di Giuda fino al punto di raccontarne un incontro come fa di solito un inviato di giornale con una celebrità. La ragione è semplice e nello stesso tempo complessa: volevo spaziare nell’affabulazione anche oltre la realtà o la verità storica. Questo spaziare, questo andare oltre, è tipico del teatro (da Shakespeare a T.S. Eliot, ma anche da Sem Benelli a Pirandello, per non dire di Brecht), giacché il teatro – col gioco delle immedesimazioni (la famosa mimesis di cui parlava Auerbach) – consente di trasferire, incarnare e sublimare quella rappresentazione che tu chiami “metafisica” e che io chiamerei anche “iper-reale”. Già, ma perché questo spaziare, perché questo spingersi fino all’impossibile? Perché chi scrive – questa è la risposta – non può fare a meno di inventare: inventare storie e personaggi, stile e linguaggio, sintassi e forma.
Ci sono quelli che inventano sugli altri e saranno soddisfatti del loro onusto orgoglio di imitatori (fraintendono e confondono la mimesis con la contaminatio), ci sono quelli che inventano sulle invenzioni altrui rispettandone moduli e strutture e riservandosi il crisma dell’originalità perché operano un’esplorazione dialettica e sincretica del codice primario o, come si dice con termine tecnico, una transcodificazione degli stili e dei linguaggi. Ebbene, che significa tutto ciò (e mi auguro di non annoiare né te né chi passa e legge)? Significa che uno scrittore autenticamente ispirato non fa altro che spaziare: da se stesso ad altri scrittori, dalle sue ad altre storie. Tutti sono autori ma non tutti sono scrittori, narratori, poeti, drammaturghi…
Veniamo al “Campo del vasaio”. La scelta primaria non è stata quella di Giuda ma della locanda, cioè di un luogo deputato, di una scena eletta a simbolo e simulacro di una realtà “inventata”. In quella locanda, come hai visto, c’è il giornalista-inviato cioè il ghost-writer, lo scrittore fantasma (alias me stesso) che si è oscurato, si è rappresentato, si è incarnato in un “personaggio” dei nostri tempi, come se i lettori del “Campo” (e dovrei dire della “Dimora”) mi o gli avessero dato la delega a rappresentarli a loro volta. Questo racconto (e non dovrei dirlo io) è un esempio di testo che coniuga il tempo interno con quello esterno (interno alla storia presentata, esterno per la percezione della lettura), di un testo che estrapola coscientemente il tratto storico-leggendario per farlo diventare materiale narrativo e drammaturgico, di un testo – infine – che rimedita stile e linguaggio di un personaggio epocale non per concludere un sommario processo di sentenza ma per illustrare un processo di consapevolezza. Non a caso l’inviato – come un equanime provocatore – dirà di non sapere cosa scriverà e infatti non ha scritto, ha raccontato. Il racconto, quindi, crea dal nulla – senza contaminare altro – una struttura di riferimento possibilmente godibile per i lettori: non si impegola in diatribe religiose o fideistiche ma opera – credimi – sulla narratività, su quella esaltante e non sempre realizzabile capacità letteraria che uno scrittore ha quando si accinge a rappresentare la realtà con il bagaglio e il corredo dei propri mezzi espressivi e del suo talento più o meno collaudato, più o meno originale.
Un abbraccio e scusami per la prolissità
Antonio
molto interessante. anche nella risposta al commento di Jolanda. Come sempre gli argomenti trattati nelle pagine di Antonio Schiavone attirano la mia attenzione. Il mio commento è solo sul sottotitolo tra parentesi (un incontro impossibile).
Perché impossibile? Quanti di noi si sono chiesti ogni volta che hanno incontrato Giuda sulle pagine del Vangelo perché abbia fatto quella fine. Comprendo la sete di denaro, comprendo il bacio, il tradimento, il fare quello che si doveva fare…ma non sono mai riuscito ad accettare che non si potesse salvare anche lui, come Pietro.
Un incontro possibile, quello con Giuda, forse necessario proprio per la sua stessa vita, era pentito ma disperato troppo disperato per aver tradito un amico con un bacio. Forse un amico, un vero amico, alla locanda o alla -dimora- lo avrebbe potuto salvare.
Mi scuso per la semplicità del mio commento e ringrazio di tutto cuore per questa bellissima lettura.
fausto
come non comprendere il suicidio ? Ci si suicida per molto molto meno.Anche solo per intolleranza alla vita,..Anche nel Vangelo, quindi, il suicida viene compreso e quello che farà Dio del suicida lo sa solo lui.
Complimenti vivissimi per questo straordinario post.!
Essendo straordinaria anche l’immagine dell’impiccagionei di questo bassorilievo sarei riconoscente a chi mi volesse segnalarne l’origine.GRAZIE!
@ Lucia. l’opera datata 1130 circa è stat realizzata dal Maestro Gislbertus e si trova nella Cattedrale si san Lazzaro a Autun , Francia
grazie 1000!
lucetta