“Il nero è il cuore della luce, è il suo nucleo originario, la cosa primultima da cui la luce è destinata e a cui si destina.
Tutto nasce dal nero e muore nel nero; e la luce è anche il transito dal nulla originario al nulla del divenire, la luce è anche l’utopia che guida i nudi piedi sui sentieri dell’indecidibilità.”
L’ipertesto della scrittura al nero
(Uno sguardo su Entrata nel nero di Ranieri Teti)
“In questo girare che è ritmo, la parola è rivolta verso ciò che distoglie e si distoglie. È una parola rara, che ignora sia la precipitazione, sia il rifiuto di andare oltre, sia il dubbio che oscilla in modo simmetrico. Nella sua stranezza è la più franca, e persiste sempre nell’interruzione, si appella sempre al percorso, e così ci tiene come in sospeso tra il visibile e l’invisibile, o al di qua dell’uno e dell’altro.
– Altra cosa difficile ad intendersi. Che significa? Ciò che non è visibile, si dovrà pur ritenerlo invisibile.
– Il fatto è che forse esistono due tipi di invisibile, uno che è un altro modo di lasciarsi vedere, e un altro che si distoglie da ogni cosa visibile e invisibile. La presenza di questo percorso è la notte, specialmente quella notte che è il dolore e quell’altra notte che è l’attesa. Parlare è la parola dell’attesa in cui le cose sono rivolte verso lo stato latente. L’attesa, lo spazio del percorso aggirante senza digressione, dell’errare senza errore. Là le cose non hanno modo di mostrarsi o di nascondersi, almeno nella misura in cui questi movimenti rappresentano dei giochi di luce. E nella parola che corrisponde all’attesa c’è una presenza manifesta con cui il giorno non ha nulla a che fare, una scoperta che scopre prima di ogni fiat lux, scoprendo l’oscuro in quel percorso che è l’essenza dell’oscurità. L’oscuro nella sua segretezza si offre al giro che originariamente governa la parola.
– Malgrado i vostri sforzi per evitare che nel parlare dell’oscuro noi si abbia a evocare la luce, non posso fare a meno di riferire ogni vostra parola al giorno come all’unica misura. Forse perché il nostro linguaggio è diventato abusivamente – necessariamente – un sistema ottico che parla solo alla nostra vista? Mi domando se Eraclito non intendesse riferirsi a questo quando, a proposito della parola sacra, diceva che non espone né nasconde, ma indica.(Maurice Blanchot, La parola plurale, in id. L’infinito intrattenimento, Trad. R. Ferrara, Einaudi, 1977, pp. 42-43)”.
Teti indica. E suggerisce.
Nessun dogma, se non quello dell’inverificabile.
Nessuna legge a cui sottostare se non, forse, la soggiacenza alla parola. Teti, soggiacendo alla parola, tenta di instaurare un regime di prossimità con essa. Si àncora alla parola pur sapendo che, prima o poi, la parola abbandonerà la prossimità per proiettarsi altrove. In tal senso la prossimità presume un abbandono. E difatti c’è un forte sentore di abbandono in queste pagine. Un abbandono che Nancy, altrove, non ha esitato a correlare con l’abbondanza.
Cos’è che abbonda qui?
Almeno due cose: il nascondimento dell’io narrante e l’aspirazione a quello che potremmo definire nascimento (anteriorità, originarietà).
Tutto avviene nel buio.
Perché nel buio?
Rispondere che il buio favorisce il nascondimento sarebbe troppo semplice e finirebbe per deviarci dalla strada maestra.
Il nero è il cuore della luce, è il suo nucleo originario, la cosa primultima da cui la luce è destinata e a cui si destina.
Tutto nasce dal nero e muore nel nero; e la luce è anche il transito dal nulla originario al nulla del divenire, la luce è anche l’utopia che guida i nudi piedi sui sentieri dell’indecidibilità.
In questo transito (“non appartenere che a transiti e mutamenti”) – tra es-posizioni e tra(n)s-posizioni – Teti declina la tramatura di una personalissima “biografia dell’oscurità”.
Ma la sola declinazione non può bastare.
Teti – conscio del valore orale della cosa poetica – si impone una scansione suggerendo le coordinate per un possibile diktat (“per voce sola”, “un richiamo dalla parte dell’eco”, “l’inserzione della lingua alla gola”).
C’è un ritmo in questo transito, c’è un’andatura specifica che permette ai piedi di marcare il passo o di sfiorare il terreno, di correre o di rallentare.
Ma partiamo dall’inizio.
mostra i denti
come bestia cerca
cibo nel buio il lume
che bagna le mani
e il silenzio del foglio
delle dita sul foglio
Il cominciamento è quello di un foglio umido e silenzioso. L’umidità è impressa sul foglio dalle dita, dita bagnate di luce, o forse di lumi e barlumi.
C’è qui un primo segno volto a configurare da un lato una dimensione aurorale e dall’altro lato una sorta di rumore di fondo, o meglio, ricordando Deguy, Saussure e Bigongiari, un “rumore senza fondo”.
Definiamo i due aspetti.
La dimensione aurorale è nell’impatto di una scrittura-luce quasi evanescente col suo destino: il foglio su cui lasciare l’impronta di quello che possiamo definire «silenzio originario».
Il “rumore senza fondo” è quello della bestia che cerca il cibo ringhiando nella notte o, se preferite, quello dell’autore la cui voce regredisce (approda?) al ringhio animale, ovvero all’impronunciabilità, o infine, per parafrasare lo stesso Bigongiari, quel grido inarticolato dell’infante appena nato (Derrida avrebbe detto appena “separato” alla nascita), un grido inarticolato che non è ancora parola ma che contiene, in sé, il segreto e la risoluzione di tutte le parole.
Il grido inarticolato dell’infante viene espulso come risposta a una cruenta delocazione da uno spazio buio (il ventre) a uno spazio, per così dire, luminoso, sicuramente abbacinante, sovraesposto e quindi cieco. Non è proprio la voce del nero, ma è la voce del cuore nero che permette l’approccio a qualsiasi tipologia di luce (lux, lumen, radianza, riflesso, svelamento, abbacinamento, ecc). È un gesto violento, se volete animale. Allo stesso modo il ringhio della bestia – che è anch’esso, in un certo senso, inarticolato – ha un cuore nero da rivendicare.
Il grido dell’infante presuppone un’originarietà dovuta a una separazione e il ringhio figura (de-figura, ri-configura) la regressione animale della parola come indicazione di percorso.
In tal senso questo libro è un neonato, un infante che rivendica la sua originarietà: il ritorno al nero, all’impronunciabile, all’inarticolato, all’inconosciuto, e quindi a tutta la serie degli elementi che costituiscono (e destituiscono) la sfera dell’innato, ovvero: a quel “rumore senza fondo” che Teti sottopone a un processo sinestetico in cui la lettura chiama a sé la voce (“dove salvarsi è stato / scrivere un grido / dimesso in suoni”).
Ma Teti non urla.
Conscio dell’investitura sacrale della (sua) parola egli indica l’urlo che soggiace tra le righe, l’urlo che fibrilla nelle pieghe della scrittura.
Teti non compie gesti violenti.
Casomai si attarda ad evidenziare gli intervalli (spaziali e spaziati) in cui coltivare l’aporia. E si attende sulla soglia sapienziale ove defigurare la dissoluzione di tutte le sue voci (quelle clamanti della regressione, quelle dolorose dell’infante, quelle involtolanti dell’origine, quelle docili e affabulanti dell’aporia ecc.) o, se preferite, della sua unica voce: il respiro.
Certo, la gabbia metrica o meglio l’organizzazione testuale in cui Teti inscrive i suoi versi aiuta non poco a conferire un ritmo e una scansione, ma questo è solo uno degli innumerevoli aspetti di una teorizzazione ben più ampia e articolata che predilige gli svuotamenti ai riempimenti, le sparizioni alle apparizioni.
Se fosse possibile la costituzione di una musica dello scarto e dello spaesamento quest’opera ne rappresenterebbe lo spartito ideale. E per spaesamento si intenda, oltre allo smarrimento, anche l’impossibilità di fissare.
L’autore non può concedersi il lusso di fissare, né dimore né parole.
Per questo forse il bianco (sempre sottinteso) e il nero (decisamente ostentato), l’ascesa e la caduta, il ritrovamento e la perdita lavorano di comune accordo e per un fine comune, qualora ci possa essere un fine nel senza-fine di un verbo destinato sempre a ricominciare (“la fine di ogni fine legata / all’inizio di tutti i partire”).
C’è, forse, una lezione tra le righe di questa scrittura.
Qual è la lezione?
È presto detto: bisogna precipitarsi e disapprendere, bisogna precipitarsi a disapprendere, farsi usare (e ab-usare) dal non-detto (anche se pesantemente presente), dall’inconoscibile, dall’inverificabile.
In poche parole: disapprendersi da tutto ciò che tenta di entrare in ciò che è già uscito (da sempre) e che tenta di uscire da tutto ciò che è destinato a restare intestino. Questo verbo, disapprendere, corrisponde molto semplicemente a «sparire». Teti sa che la forma più alta di pratica poetica è quella in cui l’autore sparisce lasciando il testo a parlare in sua vece.
Ed è anche per queste ragioni che si sfinisce (si finisce e si de-finisce) nel dire il non-detto, nel riproporre – quasi masochisticamente – le posizioni da cui decedere, nel figurare le scomparse a vista direttamente “negli occhi”, in quegli occhi la cui massima aspirazione è, forse, quella della cecità.
È sempre una questione di sguardi.
Teti cerca il presso-di-sé (il senso?) attraversando soglie, sostando in diverse dimore, ma più di ogni altra cosa egli si guarda intorno.
I suoi occhi potrebbero consegnarsi all’abbacinamento del bianco per meglio arrivare al cuore nero; così come potrebbero (e in realtà, seppur con discrezione, lo fanno) sfidare l’oscurità. Ma il presso-di-sé sfugge sempre alla presa.
Il senso, scontrandosi con il sensibile, attraversa cose ed elementi, crea distanze incolmabili, rifiuta una definizione unica e univoca e si apre anzi a ventaglio facendo sfoggio di tutti i particolari che lo (de)compongono (“il tutto in ogni parte dei frammenti”).
Il significante (in senso generale) viene da Teti continuamente spostato. Ma io vorrei qui surdeterminare il semplice spostamento in una complessa e articolata delocazione il cui compito non si esaurisce nel passaggio da uno spazio all’altro, ma deve creare dei lassi temporali e spaziali per permettere alla scrittura di agire in essi e di farsi agire da essi.
In poche parole la delocazione del significante, nella poetica tetiana, è quel gesto che permette di dare spazio allo spazio, crea spazialità e figura una spartizione dello spazio.
Lo spazio non è solo metafisico e metaforico, lo spazio è il non-luogo ove praticare il transito e il passaggio della scrittura, lo spazio è il non-luogo ove Teti si presenta al cospetto della parola.
Spartire uno spazio di questo tipo significa quindi aprirsi a diverse e svariate possibilità di senso.
Uno dei sensi primari è pressoché lampante: essendo Entrata nel nero un libro dei margini, in un regime di spartizione spaziale avviene, in prima istanza, una moltiplicazione dei margini (“margini che provano differenti prove di esodo”).
Ecco allora che Teti sottopone le cose a un procedimento metamorfico e traslando gli elementi in un sistema tropico ne diversifica la portata e il raggio d’azione. Così, a titolo di occorrenza, “mutata la linea di confine in zona di nessuno” può diventare “nei luoghi recitati a confine / da voci che guardano”.
In questo complesso regime di bordature i «margini» (rive, confini, frontiere, ecc.) divengono «argini», e ciò che sta nel mezzo è quel fiume placido e irriverente in cui scorre l’afflato della parola inconclusa e inconosciuta, quella parola il cui divenire ci ha già preceduti, da sempre e per sempre.
Qui, come già accennato, bisogna parlare di cecità, o meglio di ciò che accade in un regime al nero, o meglio ancora di ciò che non può essere verificato dagli occhi. Occhi ciechi quindi, ma (in)naturalmente portati a surdeterminare la vista verso tutto ciò che provoca uno spaesamento.
Cosa fanno questi occhi ciechi?
Molto semplicemente producono un movimento, si impegnano in un transito, cercano, in poche parole, non tanto una destinazione quanto il senso (mai ultimo e mai definitivo) del loro stesso movimento.
Il senso non deve necessariamente corrispondere alla destinazione. Anzi Teti ci fa capire che tutta la questione verte sul punto di partenza, su quella presenza/assenza originaria che è insieme estensione e intensione. Ma, in realtà, qui non ci si limita ad una origine, per così dire, semplice, bensì ci si proietta verso una pre-origine che è e resta sempre da definire.
Da qui il carattere erratico e incompiuto di tutta l’opera. Da qui anche la struttura circolare che identifica la “fine” nella “radice” e che riporta tutto allo “scorrere muto” di una “superficie / in cerca di profondità”, a quel silenzio ove ci si può concedere il lusso non di scrivere ma di essere scritti dalla propria scrittura.
______________________________
Altri interventi e selezioni di testi qui:
https://rebstein.wordpress.com/2011/05/31/entrata-nel-nero/
http://kolibris.wordpress.com/2011/06/14/alessandro-assiri-su-entrata-nel-nero-di-ranieri-teti/
http://rosapierno.blogspot.com/2011/06/ranieri-teti-entrata-nel-nero-kolibris.html
______________________________
***
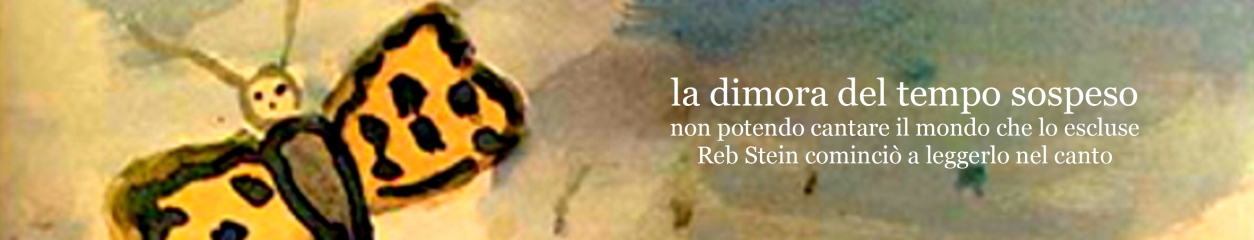

la poesia di teti è per me una piacevole scoperta.
bellissimo quel piccolo scrigno che è il suo libriccino.
Teti è un magistrale poeta, perchè prima è una grande persona vera.
Non ho letto il libro di Teti, ma conto di farlo perchè questa lettura di Enzo Campi è come sempre un invito ad approfondire, intanto auguri per il libro. Grazie a Enzo e a Francesco.
Ho letto le poesie di Teti, e trovo molto originale la visione della vita che l’autore offre alla nostra riflessione. Complimenti a lui, e grazie a Enzo Campi per la sua chiosa puntualissima.
Ho letto il libro di Ranieri, leggo il commento di Enzo. Due ottimi testi su un tema intrigante e fondamentale. Ricordo qui, perché in tema, le straordinarie fotografie del rumeno Evgen Bavcar, fotografo cieco, che ha recentemente esposto al PAC di Torino.
M
grazie marco.
non conoscevo bavcar. ho fatto una ricerca e ho trovato delle cose notevolissime. grazie per la segnalazione.
Non conoscevo Teti…il commento di Enzo spinge a “colmare questa lacuna!”…
maurizio
“Scritti dalla propria scrittura…” eh sì, è questo che accade.
Bel pezzo, me lo sono stampato e incuriosita dalla poesia di Teti che non conosco, ma colmerò la lacuna. ( coincidenza: ho appena scritto un testo intitolato Utopia della luce)
Ciao
Liliana Z.
grazie a tutti per gli interventi!
Credo che la nota di Enzo sia uno degli scritti migliori tra quanti si sono occupati della poetica di Teti. Una sorta di “critica figurale”, la sua: l’analisi dell’opera in questione, condotta con acume e competenza, finisce per gettare luce su tutto il percorso di questo autore, evidenziandone sottilmente talune linee di sviluppo fondamentali.
Buona giornata a tutti.
fm
L’analisi di Enzo è straordinaria.
La poesia di Teti ne risalta come illuminata nelle sue molteplici sfaccettature.
un caro saluto a tutti
cb
grazie cristina!
E’ una critica “testuale” rigorosissima, oggi sempre meno praticata e sostituita da scialbe e insignificanti analisi “impressionistiche” o da perlustrazioni a sfondo ideologico che bypassano la scrittura in sé, relegata a mero “accidente incipitario”.
Enzo non solo è capace di ricostruire la natura, la “consistenza” e le ragioni della trama scritturale, ma ci restituisce mappe sempre più circostanziate della galassia ideativa da cui i testi in questione nascono.
Una prassi che è ormai patrimonio di pochissimi.
fm
La luce e il buio sono due dei temi prediletti dai poeti, si prestano al contrasto, alle metafore. Si può dire tanto con poche parole, proprio per ovviare all’artificiosità del linguaggio corrente. Non avevo mai sentito rammentare il nome di Raniero Teti e non conosco la sua poesia. Non ho mai avuto occasione né di leggere né di recensire le sue opere. Dalla lettura della tua eccellente e professionalissima critica al libro del Teti, deduco che è davvero interessante e meritevole di attenzione. Complimenti a te, Enzo, per il tuo acume e all’autore per saper esprimere concetti alti e complessi nei suoi testi. Grazie per questa lettura e per avermi permesso di conoscere un nuovo poeta.
grazie nicoletta!
per chi volesse qui una selezione di testi dal libro
Mi dispiace non essere intervenuto prima. Ho letto solo adesso, di ritorno, questo straordinario saggio di Enzo Campi.
Il suo ipertesto, per struttura, articolazione, visione, analisi, lucidità a penetrare il senso e la forma, nel mio immaginario è l’ideale compagno di questo libro.
Concordo in pieno con il commento di Francesco.
Ranieri