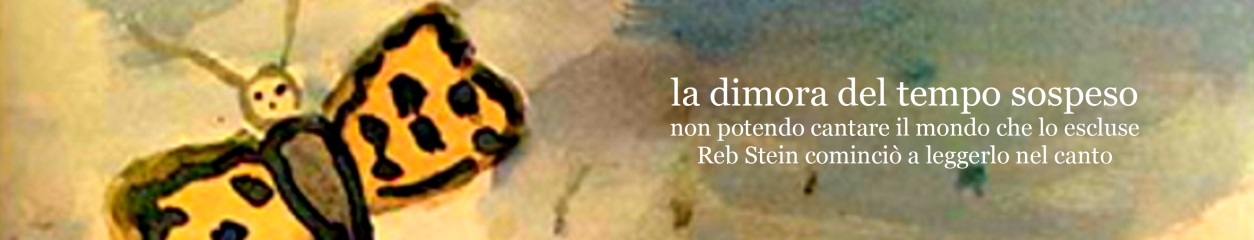Ideogramma pittorico e lingua universale (2.)

6. A circa quarant’anni di distanza da Un barbare en Asie, Michaux torna ad occuparsi della scrittura ideografica orientale, dimostrando in tal modo la costanza di certi suoi interessi. Nel 1971, infatti, scrive, come prefazione a un libro sulla calligrafia cinese, un saggio che quattro anni dopo diverrà un volumetto dal titolo Idéogrammes en Chine(36). In questa occasione, l’autore non soltanto mostra di accettare, ma anche elogia con finezza sia i segni più arcaici sia quelli più recenti (purché elevati a superiore eleganza ed efficacia dall’arte calligrafica). Egli riconosce subito che gli ideogrammi di oggi si presentano a chi li osservi “senza corpi, senza forme, senza figure, senza contorni, senza simmetria, senza un centro, senza richiamare alcunché di noto”, ma si affretta a ricordare che, all’opposto, “vi fu un’epoca in cui i segni erano ancora parlanti, o quasi, già allusivi, rivelando, più che cose, corpi o materie, rivelando gruppi, complessi, presentando situazioni”(37). In seguito, spiega, ha prevalso nei Cinesi il gusto dell’astrazione, e anche quello di celare il significato della scrittura per riservarlo a una casta di mandarini, sicché i segni sono stati deformati, perdendo la loro immediata riconoscibilità. Però gli ideogrammi antichi, incisi sulle tombe e sui vasi, si sono conservati, permettendo in seguito agli appassionati di trascriverli e di riunirli: “Nasceva un inventario, un dizionario dei segni d’origine. Ritrovati! e si ritrovava ad un tempo l’emozione delle calme e serene e tenere prime grafie. I caratteri risuscitati nella loro prima intenzione rivivevano. In questa luce ogni pagina scritta, ogni superficie coperta di caratteri, diviene brulicante e traboccante… colma di cose, di vite, di tutto quanto vi è al mondo”(38). I segni arcaici non appaiono certo a Michaux riproponibili nella realtà della Cina contemporanea, ma lo affascinano per un motivo che, pur senza essere esplicitato, ci appare ormai evidente, ossia la loro prossimità a una lingua universale, immediatamente decifrabile da tutti.
C’è stata però un’altra strada attraverso cui la scrittura cinese ha raggiunto risultati ammirevoli, vale a dire la calligrafia. Quest’arte può prescindere dal richiamo ai segni antichi, anzi “i caratteri evoluti si addicevano meglio di quelli arcaici alla velocità, all’agilità, alla gestualità viva”(39). Come per la pittura, anche per la calligrafia sono richiesti preliminarmente uno studio paziente e una grande concentrazione interiore, mentre al momento dell’esecuzione dell’opera diventa determinante “la spontaneità, che può arrivare quasi sino alla folgorazione”. E un’altra ed importante analogia con la pittura, intesa alla maniera cinese, consiste nella necessità per il calligrafo di “non più imitare la natura. Significarla. Con tratti, con slanci”(40).
Anche quando parla della Cina, Michaux si trova dunque di fronte ad una sorta di esitazione o dilemma. Il segno o ideogramma deve riprodurre visivamente la realtà, sia pure in maniera semplificata, così da diventare il carattere di una lingua comprensibile a tutti? Oppure deve svincolarsi dalla mimesi, assurgere a strumento di espressione individuale, trasformandosi in tratto pittorico capace di veicolare emozioni e sensazioni che le parole sono impotenti a comunicare? Entrambe le opzioni possono avere una loro plausibilità, ma rischiano, sul piano teorico, di escludersi a vicenda. L’autore però, per quanto lo riguarda, sembra deciso a percorrere il più a lungo possibile l’una e l’altra via.

7. Nel 1972, in una delle rarissime interviste da lui concesse, Michaux viene interrogato da Jean-Dominique Rey a proposito delle sue opere pittoriche(41). La prima domanda parte dall’ipotesi che la loro efficacia sia legata alla velocità di esecuzione. “Quest’impressione – conferma l’artista – è giusta. Per molto tempo ho usato soltanto l’acquerello, che è un medium rapidissimo. L’inchiostro consente di andare in fretta. E l’acrilico, in due tempi, ancora più in fretta. Mi stupisce sempre molto il fatto che oggi così pochi pittori pensino alla velocità, quando invece si tratta di un fenomeno fondamentale della nostra epoca. […] A differenza di chi pratica la velocità e ne è maestro, come Pollock e Mathieu, io faccio corpi in movimento, parti di disegni che lo evocano, pezzi staccati che se ne vanno via”(42). Rey gli chiede allora quale rapporto vi sia tra questi segni e il loro significato; Michaux risponde che lo spettatore è libero di interpretarli come crede: “Io fornisco una certa quantità di elementi, di segmenti animati. Per me, questo non fa parte di nulla, tutto è movimento. Se ci si vede una battaglia, una ritirata, un annegamento o, come mi diceva recentemente un giovane, una mischia amorosa – cosa che non ha mancato di sorprendermi –, si è liberi di farlo”(43). Più oltre, una domanda verte sul rapporto con l’arte dell’Estremo Oriente. Conosciamo già la risposta: “È stata una delle prime pitture che abbiano avuto valore per me […]. Mi è bastato vedere l’aria della Cina per avere il colpo di fulmine. La Cina mi ha colpito moltissimo. Qualcosa mi veniva aperto. L’ho digerito, dopo una lunga incubazione. Lo choc è stato inversamente proporzionale alla distanza”(44).
A questo punto, con grande intelligenza, Rey rileva che nei quadri di Michaux si notano dei segni che sembrano appartenere a una grafia illeggibile, e gli chiede se non siano l’indizio della ricerca di una nuova scrittura. La risposta è particolarmente importante, tanto che vale la pena di riportarla per intero: “Per un po’ ho sognato di cercare una lingua universale, ma senza ottenere risultati seri. Ho tentato di inventare dei caratteri chiari per tutti senza passare attraverso la parola. Ma non ne è uscito niente… se non un carattere mai abbastanza diverso dall’altro. Ero a lato. Nella scrittura cinese, quando si usava la penna a becco che ha preceduto il pennello, chiunque, in un attimo, poteva capire i caratteri. Ho sempre sperato di trovare questa lingua in altri, o altrove, in Africa ad esempio, ma dobbiamo riconoscere che non è mai molto chiara o che resta convenzionale: uomo, donna, montagna, ruscello, niente di più. È una speranza che non ho realizzato. Darei volentieri tutto quello che ho fatto per riuscirci. Ho voluto svolgere questa ricerca in équipe, ma ho trovato solo degli svitati come me. Tuttavia resto convinto che vi sia sempre qualcosa da fare in questo senso. Ho voluto indicare dei caratteri che abbiano un contenuto psichico. L’uomo di oggi è scontento della sua lingua… Oltre i segni della segnaletica, presto altri cinquecento segni saranno necessari nel mondo d’oggi. Esiste attualmente un problema del segnale, e del segnale non verbalizzabile, che è essenziale. Il grafismo, che ha tanti rapporti con l’uomo, diventerà sempre più ricco, sempre più preciso. Tutto quello che dico ora è solo il rimpianto di aver percepito una certa direzione di lavoro, ma di aver iniziato troppo tardi”(45).
Anche in queste dichiarazioni, l’alternativa che ci è nota si profila con chiarezza: da un lato vi sono i segni pittorici, finalizzati ad esprimere l’idea del movimento ma non direttamente imitativi, così che l’osservatore resta libero di interpretarli come crede, di vedervi ciò che preferisce; dall’altro vi sono i segni linguistici, quelli della nuova lingua delle immagini che Michaux cerca invano di raggiungere. In entrambi i casi si tratta, se si vuole, di ideogrammi, ma mentre i primi hanno già raggiunto il loro scopo quando riescono a trasmettere a chi guarda una sensazione di libertà e di movimento, i secondi, per poter funzionare, devono avere un contenuto semantico univoco, tale da poter essere riconosciuto senza incertezze da chiunque. Michaux sta cominciando a capire, e ad ammettere, che è molto più facile e gratificante per un individuo trovare un linguaggio dei segni dipinti con cui trasmettere agli altri le proprie emozioni, che non costruire ex novo i caratteri di una lingua universale. Tuttavia l’importanza estrema che egli attribuisce a quest’ultimo compito fa già intuire che – benché egli possa apparire ormai disilluso e disposto a riconoscere il fallimento dei tentativi compiuti – i suoi sogni o progetti in questa direzione non si sono estinti completamente(46).

8. Tra il 1974 e il 1984, tre volumi di Michaux ripropongono, in maniere diverse, la problematica che ci interessa. La prima di tali opere ha per titolo Par la voie des rythmes(47) ed appare come un prodotto decisamente anomalo. Ciò che sorprende non è il fatto che il libro contenga soltanto disegni (negli anni Settanta, Michaux è ormai noto e affermato come pittore e disegnatore), ma che venga edito nella veste tipografica di solito riservata ai normali testi scritti. Si ripropone dunque, in modo ancor più evidente di quanto accadeva in Mouvements o in Parcours, il problema di capire se quelli che abbiamo di fronte, su un gran numero di pagine, vanno visti come dei semplici disegni oppure come i caratteri di un’immaginaria scrittura ideografica. Tanto più che, in questo caso, la provocazione nei confronti dell’osservatore, al fine di porlo nel difficile ruolo di lettore, viene orchestrata con particolare sapienza.
I segni usati sono a volte astratti, a volte basati su immagini riconoscibili (uomini in movimento, volti stilizzati, animali, piante); su ogni foglio, essi si mostrano in numero variabile: in certi casi sono pochi e collocati sparsamente, ma di solito rispettano una disposizione su righe o colonne. Per far capire che esistono serie di immagini distinte fra loro, Michaux inserisce ogni tanto delle pagine bianche, in funzione di cesura. Ancor più significativa è un’altra configurazione spaziale, quella che prevede a sinistra una pagina bianca e a destra, al centro del foglio, dei piccoli tratti paralleli sotto cui compaiono uno o più segni, diversi caso per caso. In tal modo l’autore suggerisce visivamente l’idea che quello che abbiamo davanti è un “frontespizio”, a cui farà seguito l’inizio di un nuovo “capitolo”. A conferma di ciò, il libro si conclude con una pagina che funge da “indice”: nella colonna di sinistra, i tratti paralleli (di cui ora percepiamo con chiarezza che erano in ordine crescente, da uno a cinque, e che dunque servivano a numerare i “capitoli”), nella colonna di destra le figure che li accompagnavano sui vari “frontespizi”, che si rivelano adibite al ruolo di “titoli”.
Si potrebbe pensare che una trovata del genere abbia un valore puramente umoristico, ma sarà senz’altro più opportuno intenderla in maniera diversa. È probabile infatti che Michaux voglia farci riflettere sulla necessità di non subire troppo pesantemente il condizionamento imposto dalle abitudini e dalla forma-libro tradizionale, esortandoci ad attivare la fantasia, a tentare o a fingere (come un bambino sarebbe certo capace di fare) di riuscire a “leggere”, al modo di un normale testo stampato, una serie di segni dei quali cogliamo soltanto, e non sempre, il valore pittografico.
Nella seconda delle tre opere, Saisir(48), le intenzioni dell’autore divengono più esplicite, perché ai disegni si accompagnano dei testi che vi fanno riferimento. Anche il titolo viene chiarito immediatamente: “Chi non ha mai voluto cogliere [saisir] di più, cogliere diversamente, cogliere meglio, gli esseri e le cose, non con parole, fonemi o onomatopee, ma con segni grafici? Chi non ha voluto un giorno costituire un abbecedario, un bestiario, e persino un intero vocabolario da cui il verbale sia interamente escluso? E se tentassi ancora una volta, aprendomi per davvero agli esseri del mondo visibile? Il bestiario innanzitutto. E del movimento, perché non voglio l’immobile – o allora che vi sia del mobile nell’immobile. E tuttavia qualcosa di semplice, che possa essere maneggevole, manipolabile, perché sogno anche di fare una lingua”. Ma, riguardo a quest’ultima aspirazione, Michaux ammette subito di essere ben lontano dal raggiungere il risultato sperato, e di aver anzi dovuto rinunciare.
Il disegno stesso, inteso come raffigurazione di determinati oggetti, a cominciare appunto dagli animali, gli suscita dei problemi, perché alcune specie gli si sottraggono, risultano per lui irrappresentabili, mentre un certo privilegio viene concesso agli insetti(49). Nel corso del libro, vediamo comunque comparire un buon numero di animali, in immagini che appaiono talvolta piuttosto “realistiche” e dettagliate. La disposizione dei segni sulla pagina è imprevedibile: possono trovarsi in alto, in basso, sui margini attorno a un centro lasciato vuoto o all’opposto raggruppati al centro, disposti in colonna, spostati un po’ a destra o un po’ a sinistra rispetto all’asse mediano del foglio. Nel testo, l’autore insiste sulla sua volontà di afferrare gli elementi del mondo esterno, e sulle difficoltà che avverte a riuscirvi: “Un non so che, da decine di anni, mi sbarra la strada della somiglianza, di ogni somiglianza. Confronto negativo”. Ma ciò non dipende tanto da inabilità grafica, quanto piuttosto da una resistenza interiore alla raffigurazione mimetica: “Sfuggire, sfuggire alla similitudine, alla parentela, sfuggire ai propri ‘simili’! Disobbedire alla forma. Come se, da bambino, me lo fossi giurato”.
Michaux passa poi a rappresentare esseri umani attivi, ma come in Mouvements ridotti spesso alla sola dimensione lineare. Non gli sfugge, del resto, il fatto che il privilegio da lui concesso al dinamismo lo separa dall’impiego dei segni tipico delle scritture antiche: “I gesti, gli atteggiamenti, i movimenti, le azioni, era questo che mi trascinava, che mi incitava adesso a riprodurli. Ma in modo diverso che nelle lingue anteriori alla scrittura, nelle quali, forse per ragioni di comodità, ideogrammi e pittogrammi sono generalmente statici”. Non mancano comunque, nelle pagine di Saisir, figure di uomini distesi, intervallati da puntini, cosa che fa pensare a righe di scrittura o a una specie di codice Morse. In seguito i puntini, da soli, formano strane configurazioni, disponendosi secondo linee oblique, orizzontali o verticali: “Il cogliere si faceva sempre più astratto, diventava un cogliere la tendenza, l’accento, l’andamento, lo spazio. Cogliere ciò che è sotteso. […] Su scale che salgono, che cadono ma sempre risalgono, che vengono riafferrate, riperse… loro, tu, sé, nello spazio, in ogni spazio”.
La pagina finale è molto insolita: al centro del foglio appare una serie di dodici strisce nere parallele, di forma irregolare, che due stacchi un po’ più accentuati suddividono in tre serie di quattro “righe” ciascuna (quasi si trattasse di tre quartine in un componimento poetico). L’impressione visiva è appunto quella di un testo scritto in cui ogni parola sia stata cancellata, resa illeggibile. Se così fosse, sarebbe un altro modo per ribadire il rifiuto del verbale, a favore di una lingua diversa, puramente segnica.
L’ultima opera di cui occorre parlare è anche l’ultima pubblicata da Michaux, pochi mesi prima della morte: si intitola Par des traits(50) e presenta, come Saisir, un’alternanza di disegni e testi scritti. Questi ultimi sono due, nettamente separati fra loro e diversi per genere: il primo è una lunga poesia, mentre il secondo ha carattere saggistico. Rispetto ai volumi precedenti, in Par des traits i segni sono più astratti, e solo in rari casi alludono a forme umane o animali. Anche stavolta Michaux propone, all’inizio e a metà dell’opera, due “frontespizi”, ma con tecnica più semplice che in Par la voie des rythmes, ossia lasciando in bianco la pagina di sinistra e limitandosi a porre su quella di destra, nella posizione di solito riservata al titolo, un unico “ideogramma”. Il testo poetico ha la funzione di chiarire, fin dall’incipit, gli intenti dell’autore: “Gesti piuttosto che segni / partenze / Risveglio / altri risvegli / CON DEI TRATTI / Avvicinare, esplorare con dei tratti”. Nei versi successivi (caratterizzati da quell’andamento iterativo, anaforico, che è frequente nelle poesie dell’autore), viene enunciata l’idea che i tratti servono a suscitare, a disfare, a sbloccare, mentre rifiutano tutto ciò che costituisce ostacolo, impedimento, abitudine. In coerenza con ciò, la poesia si conclude non con parole, ma con due linee vacillanti: dei tratti, appunto.
Dopo una serie di pagine occupate unicamente da segni pittorici, si giunge al saggio finale, in cui Michaux torna a ricorrere alle parole, ma solo per esprimere disaffezione nei loro confronti, giacché il testo ha per titolo Des langues et des écritures. Pourquoi l’envie de s’en libérer. La parte scritta è accompagnata, nella banda superiore della pagina, da una serie di macchie, quasi a porle in diretto contrasto con le parole dell’uso comune. Nelle sue riflessioni, Michaux parte da una constatazione: “Non si incontrano lingue incompiute, fatte a metà, abbandonate a metà strada (o anche oltre). Quante però ce ne devono essere state, poi lasciate indietro, pre-lingue per sempre sconosciute”. Tale scomparsa non è dovuta, secondo lui, al caso: dopo la fase dei tentativi ludici, devono essere intervenute delle persone dotate di spirito pratico ad instaurare un sistema di costrizioni, volto da un lato a favorire l’apprendimento sociale delle sole lingue istituzionali, e dall’altro a scoraggiare la creazione individuale di quelle spontanee. Da tutto ciò è risultata una sorta di tirannia del verbale: “Le manette delle parole non si allenteranno più. Non mancano da nessuna parte: lingua che formerà e limiterà, raggrupperà. Che stabilisce una società, un popolo, e al tempo stesso lo rinchiude”. Ecco allora che, in nome della maggiore comodità, gli uomini sono stati spinti ad adottare “le lingue a scrittura consonantica o alfabetica, piuttosto che quelle con caratteri pittografici e ideografici”.
Eppure, in ogni epoca devono esserci stati degli individui che, magari per gioco o passatempo, hanno provato a tracciare segni di tipo pittografico, capaci da suggerire a chi li guardasse analogie con singoli elementi del reale. Molti di loro si saranno scoraggiati dopo aver creato un centinaio di segni, pensando fossero già troppi, senza riflettere sul fatto che nelle lingue alfabetiche vengono accumulate senza scrupoli anche trentamila parole. Ma Michaux formula l’ipotesi che una reazione alla situazione attuale sia già in atto: “Ora che per la prima volta ci si trova di fronte a parecchie migliaia di lingue sul pianeta, inventariate, tutte costrittive (alcune enormi, che conquistano terreno con la forza, disciplinate, usurpatrici), si riflette. Più d’uno sulla Terra, imbarazzato da questa eccessiva e importuna ricchezza, vorrebbe piuttosto una lingua modesta, più intima”. Questi dissidenti si accontenterebbero di una lingua povera, senza pretese di dominio, limitata alla sola comunicazione fra amici, ma basata su segni capaci di tradurre emozioni, di mantenere in vita il desiderio dell’espressione pittografica, “segni che consentirebbero di essere aperti al mondo in maniera diversa, creando e sviluppando nell’uomo un’altra funzione, disalienandolo”.
Da parte sua, Michaux non pretende di aver fornito in Par des traits un esempio efficace di ciò: “In questo libro non ho intrapreso nulla di simile. Un compito del genere converrebbe a dei disegnatori più aperti sul Mondo. Anziché un unico inventore, immagino piuttosto un gruppo di tre o quattro che s’intendano bene fra loro, a cui si aggiungano poi alcune personalità complementari”. Ricompare quindi il sogno, già evocato nell’intervista concessa a Rey, di un’équipe di abili ricercatori, capaci di ideare e realizzare a tavolino una nuova lingua non alfabetica.

9. Come si sarà notato, nel saggio di Par des traits Michaux non parla più di lingua universale. Sembra anzi tentare di risolvere con un compromesso (ipotizzando segni che siano decifrabili solo nell’ambito di piccoli gruppi di persone) l’ambigua compresenza, che abbiamo già rilevato, di due aspirazioni diverse: quella individuale a trovare una forma di espressione mediante tratti pittorici e quella sociale a disporre di segni comunicativi che possano essere compresi in modo pressoché univoco.
Michaux non sembra rendersi ben conto del fatto che, all’interno di ognuna delle lingue realmente esistenti, e quale che sia il sistema di scrittura da esse adottato, è già attiva una precisa dialettica fra quei due elementi che egli tenta invano di conciliare. Walter Benjamin, ad esempio, ha evidenziato “il carattere polare di ogni entità linguistica, che è al tempo stesso espressione e comunicazione”, aggiungendo che “perfezionare unilateralmente il momento comunicativo conduce di necessità alla distruzione della lingua. Ma là finisce anche, per altra via, e cioè nel silenzio mistico, l’assolutizzazione del suo carattere espressivo”(51). Se un individuo sviluppa in modo iperbolico l’aspetto espressivo della lingua, inventandone una che sia soltanto sua, riduce inevitabilmente, e può giungere fino ad annullare, l’aspetto comunicativo; se viceversa egli punta in maniera esclusiva su quest’ultimo aspetto, finisce coll’adottare una lingua del tutto piatta e inespressiva. E ciò vale anche per le scritture ideografiche: i calligrafi dell’Estremo Oriente spesso “personalizzano” a tal punto gli ideogrammi che tracciano col pennello da renderli difficilmente leggibili, e viceversa l’ideogramma in forma standardizzata può apparire – a chi sia immerso in quella particolare cultura linguistica – come visivamente inespressivo.
Michaux ha perseguito entrambe le strade che potevano permettergli di intensificare il carattere espressivo della lingua. Non si è limitato a tentare di coniare nuove parole, ma ha realizzato anche immagini che oscillano fra il pittogramma e il puro tratto asemantico. Va detto anzi che, delle due direzioni di ricerca, è stata proprio quella affidata ai segni visivi ad essere coltivata dall’autore in modo più assiduo. Ma per quanto l’opera grafica e pittorica di Michaux tenda spesso (e non solo nei volumi che abbiamo ricordato) a proporre l’immagine di una nuova scrittura, in realtà si tratta di una semplice impressione trasmessa all’osservatore, e non di un conseguimento effettivo. Senza nulla togliere alla riuscita estetica di tali opere, è giusto ricordare, come ha fatto Jean Louis Schefer, che “il poeta sogna, e finge soltanto di scrivere. […]. Aspetta che i segni parlino. Ma essi parlano senza tuttavia raccontare alcunché. Frusciano, si fermano, si pavoneggiano: recitano il loro poema, cioè mostrano, allineano, ora come banchi di uccelli remiganti, ora come animali danzanti o colonne di ideogrammi, le cifre di una incomprensibile addizione di movimenti e di corpi, di esitazioni, di salti, di passi falsi”(52).
Dunque, in quei tratti che animano in modo affascinante i fogli disegnati da Michaux sarebbe vano cercare i germi di una futura lingua pittografica o ideografica, mentre è più proficuo vedervi dei segni dotati di valore pittorico. Come direbbe l’autore stesso, con una formula che li descrive efficacemente: “Di nessuna lingua, la scrittura. / Senza appartenenza, senza filiazione / Linee, soltanto linee”(53).
[Tratto da: Giuseppe Zuccarino, Percorsi anomali, Pasian di Prato (UD), Campanotto Editore, “Le carte francesi”, 2002]
______________________________
NOTE
(36) H. Michaux, prefazione a Tchang Long Yan, La calligraphie chinoise. Un art à quatre dimensions, Paris, Club français du livre, 1971, ripresa poi come plaquette col titolo Idéogrammes en Chine, Montpellier, Fata Morgana, 1975 (tr. it. H. Michaux, Ideogrammi in Cina, Milano, Scheiwiller, 1978) e infine all’interno del volume Affrontements, Paris, Gallimard, 1986, pp. 71-109. Il testo è accompagnato dalla riproduzione ad inchiostro rosso di ideogrammi di epoche diverse.
(37) Idéogrammes en Chine, in Affrontements, cit., pp. 75-77 (tr. it. pp. 11-13).
(38) Ibid., p. 85 (tr. it. p. 21).
(39) Ibid., p. 95 (tr. it. p. 31).
(40) Ibid., p. 99 (tr. it. p. 35).
(41) J.-D. Rey, Henri Michaux. Rencontre, Creil, Dumerchez, 1994 (tr. it. Henri Michaux. Un incontro, in Sulla via dei segni, cit., pp. 59-65); il testo è stato ripreso, col titolo Henri Michaux ou l’expérience des signes e con l’aggiunta di un breve paragrafo finale, in un altro volume di Rey, Henri Michaux, Uchac-et-Parentis, L’Atelier des Brisants, 2001.
(42) Henri Michaux ou l’expérience des signes, cit., p. 18-19 (tr. it. p. 61).
(43) Ibid., pp. 19-22 (tr. it. p. 62).
(44) Ibid., p. 24 (tr. it. p. 63).
(45) Ibid., pp. 25-28 (tr. it. pp. 63-64).
(46) Lo conferma un passo di un altro libro: “Da bambino, non capivo gli altri. E loro non capivano me. Li trovavo assurdi. Eravamo estranei. Da allora, le cose sono migliorate. Tuttavia, l’impressione che non ci si capisca realmente è rimasta. Ah! se ci fosse una lingua universale con cui ci si capisse davvero tutti, uomini, cani, bambini, e non solo un po’, con riserva. Il desiderio, l’appello e il miraggio di una vera lingua diretta sussistono in me malgrado tutto” (H. Michaux, Façons d’endormi, façons d’éveillé, Paris, Gallimard, 1969; 1989, pp. 38-39).
(47) H. Michaux, Par la voie des rythmes, Montpellier, Fata Morgana, 1974.
(48) H. Michaux, Saisir, Montpellier, Fata Morgana, 1979 (le pagine del volume non sono numerate, quindi le citazioni si intendono riferite semplicemente al libro).
(49) Ciò può dipendere dalle abitudini dell’autore, che altrove dichiara: “Nella mia vita e nei miei gusti, gli insetti sono ciò che preferisco osservare, in modo diretto o con la lente, e per ore” (Façons d’endormi, façons d’éveillé, cit., p. 51).
(50) H. Michaux, Par des traits, Montpellier, Fata Morgana, 1984 (anche in questo libro le pagine non sono numerate).
(51) W. Benjamin, Diario moscovita (1927), in Opere complete, II, tr. it. Torino, Einaudi, 2001, p. 541.
(52) J. L. Schefer, Henri Michaux. Histoires d’encres, Paris, Galerie Berthet-Aittouarès, 1999 (tr. it. Henri Michaux. Storie d’inchiostro, Milano, Pagine d’Arte, 2000, p. 12).
(53) H. Michaux, Lignes, in Lignes – Lieux, moments, traversées du temps – Ombres pour l’éternité, Poitiers, Éditions Promesse, 1967 (tr. it. Linee, in H. Michaux, Ombre per l’eternità, Milano, Scheiwiller, 1973, p. 17).
______________________________
***