Maurice Blanchot
Georges Bataille
Giuseppe Zuccarino
[Un brano di Maurice Blanchot e un saggio di Georges Bataille (sullo stesso Blanchot): due scritti poco conosciuti, praticamente inediti (o quasi) alle nostre latitudini, curati e tradotti da Giuseppe Zuccarino.]
Maurice Blanchot – Il ritorno
In assenza dell’amica che viveva con lei, la porta fu aperta da Judith. La mia sorpresa fu estrema, inestricabile, certo molto maggiore che se l’avessi incontrata per caso. Lo stupore era tale da esprimersi dentro di me con queste parole: «Mio Dio! ancora una faccia nota!». (Forse la mia decisione di procedere dritto contro quel volto era stata così forte da renderla inattuabile.) Ma c’era anche l’imbarazzo di essere venuto a verificare sul posto la continuità delle cose. Il tempo era trascorso, e tuttavia non era trascorso; in ciò vi era una verità a cui non avrei dovuto desiderare di pormi di fronte.
Dal lato di quel volto, non so se la sorpresa si confacesse alla mia. In ogni modo, esisteva evidentemente tra noi un tale accumulo di eventi, di realtà smisurate, di tormenti, di pensieri incredibili, ed anche una tale profondità di felice oblio che non le costava nessuna fatica non stupirsi di me. La trovai singolarmente immutata. Le camerette erano state trasformate, come vidi subito, ma anche in questa nuova cornice, che non riuscivo ancora a cogliere e che mi piaceva poco, lei era del tutto identica, fedele non solo ai suoi lineamenti, al suo aspetto, ma anche alla sua età: di una giovinezza che la rendeva stranamente somigliante. Non smettevo di guardarla, mi dicevo: Ecco dunque da dove veniva il mio stupore. Il suo viso, o piuttosto l’espressione, che non variava quasi mai, a metà strada fra il sorriso più lieto e il più freddo riserbo, risuscitava in me un ricordo terribilmente lontano, ed è quel ricordo, sepolto in profondità, più ancora che vecchio, che lei sembrava copiare per poter apparire così giovane. Finii col dirle: «Davvero sei cambiata pochissimo!». Era accanto a un pianoforte che non avrei mai immaginato potesse trovarsi in quella stanza. Perché un pianoforte? «Sei tu che suoni il piano?». Lei fece segno di no. Dopo una pausa piuttosto lunga, con una brusca animazione e un tono di rimprovero, mi disse: «Ma è Claudia che lo suona! È una cantante!». Mi guardava in maniera strana, spontanea, vivace, e tuttavia di lato. Quello sguardo, non so perché, mi diede un colpo al cuore. «Chi è Claudia?». Lei non rispose, e di nuovo fui colpito, ma stavolta come da una disgrazia, colpito fino all’ansia, da quell’aria di somiglianza che la caratterizzava e che la rendeva così assolutamente giovane. Ora me la ricordavo molto meglio. Aveva il viso più fine, voglio dire che nei suoi tratti c’era una specie di allegria e di estrema fragilità, come se fosse alla mercé di un aspetto diverso, più concentrato, interiore, e che l’età chiedeva solo di poter consolidare. Ma è proprio quanto non era accaduto, poiché l’età era stata stranamente ridotta all’impotenza. Dopo tutto, per quale motivo avrebbe dovuto cambiare? il passato non era così lontano, e neppure questa poteva essere una così grande disgrazia. E io stesso, come negarlo? ora che potevo guardarla dal fondo del mio ricordo, ero sollevato, ricondotto verso un’altra vita. Sì, uno strano movimento veniva verso di me, una possibilità che non avevo dimenticato, che si burlava dei giorni, che irradiava attraverso la notte più scura, una potenza senza sguardo, contro cui lo stupore, l’angoscia, non avevano alcun potere.
Dato che la finestra era aperta, lei si alzò per andare a chiuderla. Fino a quel momento – me ne resi conto di colpo – la strada aveva continuato a passare attraverso la stanza. Non so se tutto quel rumore le desse fastidio; credo che se ne curasse pochissimo; ma quando si volse e mi vide, ebbi la brusca sensazione che cominciasse solo allora a vedermi. Cosa degna di nota, lo accettai e anzi, nello stesso istante, sentii, in maniera ancora vaga ma già con forza, che in parte era per colpa mia: sì, mi accorsi subito del fatto che, se in certo modo le ero sfuggito – ed era forse strano –, era perché non avevo fatto tutto ciò che dovevo per cadere davvero sotto il suo sguardo, ed era una cosa triste ancor più che insolita. Per un motivo o per l’altro, ma forse perché ero stato io stesso troppo impegnato a guardarla a mio piacimento, qualcosa di essenziale, che poteva accadere solo su mia sollecitazione, era stato dimenticato, e per ora ignoravo cosa fosse, ma l’oblio era presente al massimo grado, tanto da consentirmi di sospettare, soprattutto adesso che la stanza era chiusa, che a parte l’oblio non vi fosse granché, lì dentro.
Fu, devo dirlo, una scoperta così rovinosa sul piano fisico che mi scombussolò del tutto. Pensandoci, fui affascinato, cancellato dal mio stesso pensiero. Ebbene, era un’idea! e non un’idea qualsiasi, ma un’idea alla mia misura, esattamente uguale a me, e se si lasciava pensare, non potevo far altro che sparire. Dopo un istante, fui costretto a chiedere un bicchiere d’acqua. Le parole: «Dammi un bicchiere d’acqua», mi lasciarono la sensazione di un freddo terribile. Ero indolenzito, ma pienamente rinvenuto, e in particolare non avevo alcun dubbio su cosa mi fosse successo. Quando decisi di cavarmi d’impiccio, cercai di ricordare dove fosse la cucina. Nel corridoio, il buio era eccessivo, e da questo capii che non stavo ancora molto bene. Da una parte c’era il bagno, che comunicava con la stanza da cui ero appena uscito, più oltre dovevano esserci la cucina e la seconda stanza: tutto era chiaro nella mia mente, ma non al di fuori di essa. Dannato corridoio, pensai, era dunque così lungo? Quando, adesso, ripenso a quel tentativo, mi stupisco di aver potuto compiere simili sforzi senza rendermi conto del perché mi costassero tanta fatica. Non sono neanche sicuro di aver provato una sensazione spiacevole fino al punto in cui, a seguito di un movimento sbagliato (avevo forse urtato nel muro), sentii un dolore atroce, il più forte possibile – mi spaccava la testa –, ma forse più forte che vivo; è difficile esprimere quel che aveva di crudele e nel contempo di insignificante: una violenza orribile, un abominio, tanto più intollerabile per il fatto che sembrava raggiungermi attraverso uno strato favoloso di tempo che bruciava per intero dentro di me, dolore immenso e unico, come se non ne fossi stato colpito in quel momento, ma secoli fa, e da secoli, e quel che c’era di passato, di completamente morto, aveva il potere di renderlo più facile ma anche più difficile da sopportare, facendone una perseveranza del tutto fredda, impersonale, che non interrompeva né la vita né la fine della vita. Certo, non compresi subito tutto ciò. Fui soltanto attraversato da una sensazione di spavento, e da queste parole, che dimostrano la mia buona fede: «Sta forse ricominciando? Di nuovo! di nuovo!». In ogni caso, fui bloccato di netto. Qualunque fosse la causa, il colpo mi aveva raggiunto con un vigore tale che, nell’istante aperto da esso, ero abbastanza al largo da dimenticare in eterno di potermela cavare. Camminare, andare avanti, mi era possibile, e dovetti farlo, ma al modo di un bue accoppato: erano i passi dell’immobilità. Quei momenti furono i più penosi. È pur vero che restano validi ancora adesso; attraverso tutto, devo volgermi verso di essi e dirmi: Ci sono ancora, sono rimasto là.
Il corridoio conduceva alla stanza che si trovava all’altra estremità. Tutto fa pensare che io avessi un’aria atrocemente smarrita; entrai quasi senza accorgermene, senza avere la sensazione di spostarmi, impegnato in una caduta stazionaria, incapace di vedere, lontanissimo dal rendermene conto. Probabilmente rimasi fermo sulla soglia. Malgrado tutto, lì c’era un passaggio, uno spessore che aveva leggi o esigenze sue proprie. Finalmente – finalmente? – il passaggio risultò libero e, dopo aver varcato l’entrata, feci due o tre passi nella camera. Per fortuna (ma quest’impressione era forse giusta solo per me), camminavo con una certa discrezione. Per fortuna anche, da quando ero entrato realmente, un po’ di quella realtà mi raggiungeva. Nel frattempo il pomeriggio aveva fatto un serio balzo in avanti, ma c’era abbastanza luce perché potessi sopportare la cosa. O almeno ne ebbi la sensazione, come pure riconobbi nella calma, nella pazienza e nella debolezza della luce la preoccupazione di rispettare in me la vita ancora così debole. Ciò che non vedevo, ciò che vidi solo all’ultimo momento…, ma su tutto questo vorrei poter passare rapidamente. Avverto spesso un infinito desiderio di abbreviare, desiderio impotente, perché mi sarebbe fin troppo facile soddisfarlo; per forte che sia, è troppo debole per la smisurata potenza che c’è in me di realizzarlo. Ah! desiderare non serve a nulla.
Di quella giovane donna che mi aveva aperto la porta, a cui avevo rivolto la parola, e che, dal passato al presente, per un tempo inestimabile, era stata così vera da rimanere costantemente visibile ai miei occhi: di lei, per sempre, vorrei non dire nulla. Nella necessità che ho di citarla, di farla venire in luce, attraverso circostanze che, per quanto misteriose, restano proprie degli esseri viventi, c’è una violenza che mi fa orrore. Da ciò dipende, almeno nella sua parte nobile, il mio desiderio di tagliar corto. Quel che l’essenziale, tramite questo desiderio, vorrebbe da me, è che io passassi sopra l’essenziale. Che la cosa avvenga, se è possibile. Supplico il mio declino di venire da sé.
Vedevo benissimo certi aspetti della stanza, che aveva ristabilito la sua alleanza con me, ma quella donna non la vedevo. Non so perché. Guardai subito con interesse una grande poltrona posta all’estremità del letto (dovevo dunque aver fatto parecchi passi per arrivare fino al fondo del letto); notai, nell’angolo vicino alla finestra, un tavolino con un grazioso specchio, ma non mi venne in mente la parola esatta per definire quel mobile. Allora ero vicino alla finestra, mi sentivo quasi bene, e se è vero che la luce si abbassava tanto più velocemente quanto più si accresceva in me, quel poco di lucidità che rimaneva da una parte e dall’altra era sufficiente a mostrarmi tutto in maniera non illusoria. Posso persino dire che, anche se mi sentivo un po’ spaesato in quella stanza, un simile spaesamento aveva la naturalezza di una visita qualunque a casa di una persona qualunque, in una delle mille camere in cui sarei potuto entrare.
L’unica anomalia che restava, il fatto cioè che non vi fosse nessuno – o almeno che io non vedessi nessuno – non disturbava affatto quella naturalezza. Per quanto mi è dato sapere, trovavo la situazione perfetta, non desideravo veder aprirsi la porta ed entrare l’inquilino o l’inquilina che di solito abitava lì. Per farla breve, non avevo idea che qualcuno abitasse nella stanza, o in qualunque altra stanza del mondo, ammesso che ce ne fossero, cosa che non mi veniva neppure in mente. Credo che in quel momento il mondo, per me, fosse interamente rappresentato da quella stanza, col suo letto in mezzo, la poltrona e il mobiletto. E in verità, da dove avrebbe potuto provenire una cosa qualsiasi? Sarebbe stato folle sperare che i muri si cancellassero. D’altronde, non avvertivo il vuoto.
Ebbene, lei – a quanto dice – mi vedeva; stava in piedi proprio di fronte alla poltrona e non si era persa nessuno dei miei movimenti. È vero, ero rimasto parecchi minuti vicino alla porta, ma non con quell’aria atrocemente smarrita che credevo di avere; sì, piuttosto pallido e con un’espressione fredda, «fissa», diceva lei, da cui si capiva bene – ma questo, nondimeno, era un po’ angosciante – che la mia vita si svolgeva altrove e che lì non poteva esserci, di me, se non quell’eterna immobilità. È vero anche che avevo fatto qualche passo; procedendo vicino alla poltrona, ero venuto a guardare con interesse il mobiletto, si vedeva bene che mi incuriosiva, vi avevo trovato qualcosa come il motivo che mi giustificava per il fatto di essere entrato. No, non si stupiva di vedermi così poco attento alla sua presenza – perché neppure lei, in quel momento, si preoccupava di sapere se fosse presente, in quanto, benché il fatto di essere respinta nell’ombra comporti qualche sacrificio, trovava un’infinita soddisfazione nel guardarmi nella mia verità, io che, non vedendola e non vedendo nessuno, mi mostravo nella sincerità propria di un uomo quand’è da solo. Chi non ha mai avuto il desiderio di guardare la verità in carne ed ossa, anche se per far ciò è necessario rimanere invisibili, anche se occorre immergersi per sempre nella discrezione del freddo più disperato e della separazione più radicale? Ma chi ha avuto un simile coraggio? Una sola persona, mi pare.
Perché non la vidi? Come ho detto, non lo so con chiarezza. È difficile tornare su un’impossibilità dopo che la si è superata, e ancor più difficile quando non si è certi che l’impossibilità non permanga. Gli uomini che passano e non s’incontrano sono innumerevoli, nessuno lo giudica scandaloso; chi vorrebbe farsi vedere da tutti? Ma forse io ero anche tutti, il gran numero e la moltitudine inesauribile, chi potrebbe stabilirlo? Quella stanza era per me il mondo e, in rapporto alla mia scarsità di forze e di interesse, aveva l’immensità del mondo: come pretendere da uno sguardo che attraversi l’universo? Cosa c’è di strano nel fatto di non vedere quel che è lontano, quando persino ciò che è vicino è invisibile? Sì, l’inesplicabile non sta nella mia ignoranza, ma nel fatto che essa abbia ceduto. Troverei ingiusto, ma conforme alle leggi, il non aver potuto rompere l’infinito o strappare a tutte le eventualità quell’unica che possa essere detta fortunata. Fortuna aspra, piena di sventura, ma pur sempre fortuna! Io l’ho avuta e, anche se l’ho persa, la possiedo ancora e per sempre. È di questo che bisognerebbe stupirsi.
Le cose si chiarirono, in apparenza (in apparenza? era già molto). Quando mi trovai vicinissimo a lei, a due passi dalla poltrona, poté non soltanto vedermi meglio – avevo il volto più livido che pallido, la fronte crudelmente gonfia – ma quasi toccarmi. Questa sensazione di avermi sfiorato le parve delle più strane e le impedì ogni altra riflessione: vi era in ciò qualcosa di inatteso, e anche di più, una luce che un secondo prima non aveva neppure intravisto. Mi seguì, ormai, con altri occhi. Esistevo? Ma se era così, forse esistevo anche per lei! La vita, si disse, ed ebbe di colpo l’immensa forza di gridare verso di me, e mentre mi chinavo sugli oggetti della toletta, emise in effetti un grido che le parve nascere, sgorgare dal vivo ricordo del suo nome, ma – perché? – per coraggioso che fosse non superò i suoi limiti, non mi raggiunse e, a causa di ciò, neppure lei poté sentirlo. Forse si rassegnò. Dato che la luce si abbassava molto rapidamente, vedeva sempre meno quel che accadeva nella stanza. Certo, era una stanza, ma tuttavia lo era così poco, e la certezza non poteva risiedere fra quattro mura; quale certezza? lo ignorava, era qualcosa che somigliava a lei stessa, e la faceva somigliare al freddo e alla tranquillità della trasparenza.
Era anche la fierezza! l’affermazione selvaggia e senza diritto, il patto concluso con ciò che sfida l’origine, oh strana e terribile tranquillità! Lei passava misteriosamente, lontana dalle menzogne visibili, evidente al massimo grado, e il terrore, che aveva pur dovuto provare, di perdersi e di ricominciare sempre a perdersi nell’evidenza senza limiti, apparentemente non era stato maggiore della semplice paura di una ragazzina che nel tardo pomeriggio, in un giardino, incontra di colpo il buio. La vita, si ripeteva, ma la parola non era già più pronunciata da nessuno, non s’indirizzava affatto a me. La vita, adesso, era una specie di scommessa che si delineava tutt’attorno, assieme al ricordo di quello sfioramento – c’era stato davvero? –, a quella sensazione sorprendente – sarebbe persistita? – che non soltanto non si cancellava, ma si rafforzava, anch’essa, alla maniera selvaggia di ciò che non può aver fine, che sempre avrebbe avanzato le sue pretese, si sarebbe mostrato esigente, sensazione che già si era messa in movimento, vagava e vagava come una cosa cieca, senza scopo e tuttavia sempre più avida, incapace di cercare ma impegnata a girare sempre più veloce in una vertigine furiosa, senza voce, murata: un desiderio, un brivido tramutato in pietra. Che io l’abbia presentita, è possibile (ma questo presentimento, non l’avevo avuto molto prima? senza di esso, sarei forse entrato?). Che lei si sia eretta allora di fronte a me, non come una vana irrealtà, ma come l’imminenza di una raffica monumentale, come lo spessore, all’infinito, di un respiro di granito precipitatosi contro la mia fronte, è vero, ma neppure quest’urto era una verità nuova, né lo era il grido che mi venne, né quello che udii; nuova fu solo l’immensa sorpresa della calma, silenzio improvviso che bloccava tutto. Ciò produsse un grande intervallo, ma qual era il suo significato: riposo dopo l’annientamento? gloria del penultimo giorno? Non avevo quasi il tempo di domandarmelo, avevo solo quello di cogliere, di sorprendere anch’io la verità di quello sfioramento e di chiederle: «Ma come, eri qui? Adesso?».
***
Georges Bataille – Maurice Blanchot
Maurice Blanchot non può figurare nel numero degli scrittori francesi più letti. Della sua notorietà è lecito dire, al massimo, che molte persone al corrente dell’attualità letteraria riconoscono in lui il più notevole dei critici viventi. Ma i suoi romanzi hanno suscitato antipatia e soprattutto il senso generale della sua opera letteraria, in parte critica e in parte romanzesca, è sfuggito, per così dire, a tutti.
Nondimeno, quest’opera colloca l’autore al di fuori delle vie già tracciate: egli è proprio lo spirito più originale del suo tempo, ossia quello che ha rivelato gli aspetti più strani, più inattesi dell’orizzonte che l’esistenza umana apre a se stessa.
Volendo indicare il posto occupato da Blanchot fra gli scrittori, è possibile, a rigore, nominare Kierkegaard, Nietzsche o Kafka… Ma a condizione di aggiungere che sarebbe vano classificarlo in qualunque modo, perlomeno altrettanto vano quanto lo sarebbe classificare uno di questi nomi.
Ecco innanzitutto, in poche frasi, gli aspetti esteriori della sua opera. Ancora giovane, Maurice Blanchot ha collaborato all’editoriale del «Journal des débats». Dopo il 1940 ha rinunciato a tale collaborazione, ormai soggetta alla censura, e si è accontentato di spedire al giornale una serie di interventi di argomento letterario. La serie ha costituito l’origine, del tutto occasionale, della sua opera critica, che oggi egli porta avanti nella cronaca della «Nouvelle Revue Française». Ma già in anni più remoti aveva cominciato a scrivere dei romanzi e dei racconti di un carattere alquanto strano, che colpiscono non solo per la maestria formale, ma anche per l’indifferenza alla realtà: l’azione di questi libri è essenzialmente interiore e profonda, procede con rigore, ma in un mondo aperto a tutte le possibilità oniriche, al tormento fantastico e illimitato che è tipico della solitudine. I testi di cui parliamo, spesso molto ampi, sono stati pubblicati solo a partire dal 1941. Li hanno seguiti, fra il 1948 e il 1953, tre piccoli libri definiti «racconti», che fanno tutti riferimento a una stessa esperienza. Questa differisce poco, come punto d’avvio, da quella descritta nei «romanzi» precedenti, e se entra, con un movimento estremamente deciso, in un mondo concreto di morte e di amore, è per ridurlo a una realtà che si disfa, allo stesso modo in cui si disfa, in un immenso irradiare, la realtà dei grandi mistici. Solo l’esistenza umana è in causa in questi racconti, ma essa spaventa, partecipa della gioia e della bufera ed è inafferrabile in misura non minore di quella divina. Tale esperienza aspra e sconcertante è l’essenziale, assai poco conosciuto, dell’opera di Blanchot, di cui la critica, per grande che sia l’interesse che suscita, con analisi che lasciano a volte stupefatti per la loro profondità, costituisce soltanto l’aspetto secondario ma più accessibile.
Ciò che, nella critica di Blanchot, si nota immediatamente è che essa non dipende in alcun modo dalla tradizione francese della critica. Sarebbe impossibile citare al suo riguardo il nome di uno qualunque dei grandi critici francesi. Se questi studi dipendono da una tradizione, è piuttosto alla filosofia che dobbiamo pensare, specie alla filosofia tedesca. Essi prolungano la fenomenologia della letteratura così come è stata sviluppata da Hegel (benché il pensiero di Blanchot sia radicalmente diverso da quello hegeliano), oppure la teoria della poesia quale è stata tentata da Heidegger in riferimento ad Hölderlin. Ciò non impedisce affatto a Blanchot di rispettare il principio francese della chiarezza. Ma solo a volte. Lo si vede nel magistrale studio che egli ha dedicato a Sade (apparso qualche anno fa in traduzione inglese nell’ultimo dei fascicoli della rivista «Horizon»); tuttavia Blanchot, che di solito considera gli aspetti più singolari della letteratura, e che d’altronde pubblica in una lingua e in un paese in cui gli scrittori si indirizzano spesso a un’élite, non esita – anzi forse esita sempre meno – a perdersi in considerazioni così profonde che diventa difficile seguirlo. Secondo lui, è strano il fatto che esistano dei libri, che delle persone inizino a scrivere e che i loro pensieri proseguano nella mente dei lettori. La condizione dello scrittore, a suo avviso, è quella di chi si trova situato come una verità fra i vivi e i morti. Talvolta lo scrittore apre la vita alla fascinazione della morte. E Blanchot può dire di sé che, se parla, è la morte che parla in lui. Di fatto, la letteratura gli appare simile alla fiamma nella lampada: quel che la fiamma consuma è la vita, ma la fiamma è vita in quanto è morte, nella misura appunto in cui muore, esaurisce la vita bruciando. Solo la nostra morte definitiva pone fine a questa morte incessante, dalla quale siamo strappati all’essere sperimentale e rinviati all’informe finzione del tutto. Con la sua ambiguità, col gioco che essa pone al posto del lavoro, con quella specie di brulicare di parassiti che sostituisce alla stabilità del mondo «reale», la letteratura ha consacrato lo scrittore – e persino il lettore – a qualcosa di diverso dal mondo effettivo. Una simile descrizione, che presenta aspetti oscuri, prende in esame una creazione che è lecito definire insospettata, una creazione che assegna all’esistenza umana una realtà che va oltre ogni realtà.
Blanchot ha immaginato il silenzio che seguirebbe la soppressione, o la cessazione, di quel gioco universale che è la letteratura, soppressione concepibile, dice, «se più nessuno parlasse in quella maniera inebriante che è la parola delle opere accompagnata dal clamore della loro fama». Si tratta in effetti, per Blanchot, di un gioco mortale per essenza, suscettibile di sparire, e con la sua cessazione noi smetteremmo di essere partecipi della morte.
Un simile modo di vedere ci allontana, senza dubbio, dalla rappresentazione abituale di un esercizio in cui spesso non vediamo altro che un divertimento, pur sapendo che in ogni istante può volgere al tragico. In un certo senso, Blanchot ammette da subito questo carattere ambiguo, ma nessuno come lui aveva saputo mettere l’accento sull’importanza di un ambito aperto al più terribile. Il mondo sacro è apparso, ricco delle sue visioni sovrane, in una danza delle parole che esprimono, a beneficio di tutti, le possibilità di terrore e di estasi dell’esperienza religiosa. E il linguaggio non ha perso la capacità di creare nei limiti – e oltre i limiti – già dati in questo campo. Conformemente alla sua ambiguità, la letteratura può anche inclinare verso l’altro lato, nel quale utilizza il linguaggio per nominare i contenuti del mondo reale, descriverne il movimento, limitandosi ad arricchirlo senza scopo, tramite la facoltà che ha di scivolare verso quel brulichio spettrale che le è proprio, che è la sua vita d’inferno o piuttosto la vita della morte presente in essa. Ma la letteratura conserva comunque il potere di nominare l’ineffabile – e l’innominabile – e, nominandoli, di raggiungere il punto più lontano. L’esperienza che resta così il suo ambito non è paragonabile, a rigore, se non a quella suscitata talvolta dalle religioni. A partire da qui, possiamo presentire diverse possibilità offerte al lavoro della critica. Quale che sia il valore da noi attribuito alle varie creazioni del linguaggio – antiche e recenti, consacrate dalla religione o votate a una relativa solitudine – è possibile fare di esse un oggetto di studio e descriverle. In tal senso, possiamo definire ciò che il linguaggio genera, ciò che crea, come se una realtà nuova, ma limitabile, si aggiungesse a quella che il linguaggio descrive senza averla creata per intero. Tutta l’opera di Blanchot distoglie da un simile percorso facile, e in essa la realtà nuova appare illimitata. Anzi, vi appare solo sotto l’aspetto vertiginoso dell’illimitato, ed è in questo che è letteratura prima di essere critica, è in questo che la creazione letteraria (i romanzi, i racconti di Maurice Blanchot) è in ogni senso preliminare rispetto allo studio delle diverse creazioni accessibili alla letteratura del nostro tempo. Ciò che conta in quest’opera, al di là degli studi critici pubblicati in Faux pas o La part du feu – e prima di essi –, sono i romanzi e più ancora quei tre «racconti» che formano un trittico: L’arrêt de mort, Au moment voulu e Celui qui ne m’accompagnait pas. Se Blanchot avesse descritto, in maniera sistematica, la realtà nuova generata dalla letteratura, avrebbe fatto opera di filosofo – di critico filosofo, ma essenzialmente di filosofo. E forse, a rigore, implicitamente lo ha fatto. È possibile ricavare dalle sue analisi una descrizione dell’essere colto nelle apparizioni e nelle distruzioni delle opere di linguaggio, di quella «parola delle opere accompagnata dal clamore della loro fama». Ma, appunto, tale descrizione non è stata per Blanchot un sostituto delle opere stesse. Essa sarebbe banale in confronto al gioioso vacillare della realtà, alla tragedia impotente di cui le opere sono un racconto fedele, preciso e fantastico. Grazie ad un dono della sua serietà, Blanchot, al contrario, sostituisce tali opere a una filosofia della letteratura… Ma la letteratura in generale è ancora filosofia, è un’entità descrivibile in termini filosofici, mentre un’opera particolare è il movimento della letteratura, ossia un’esperienza: non una filosofia, ma l’ammissione di impotenza del linguaggio che non può nominare una volta per tutte ciò che è.
Senza dubbio, l’opera critica dell’autore contribuisce a una simile ammissione.
Ma la sua opera letteraria personale ha, in tal senso, un valore privilegiato. Questi racconti di un’esperienza si riferiscono in effetti all’esperienza dello scrittore: costituiscono così un mito della creazione letteraria. Blanchot è talmente vicino a certe severità del surrealismo (pur essendo agli antipodi rispetto alle facilità di esso) che sarebbe impossibile pensare ad una qualche vuota fabbricazione teorica. Ma è uno scrittore, e la sua esperienza è quella di uno scrittore preso nello sconvolgimento della creazione. Ciò non si coglie necessariamente. I primi due racconti, il primo soprattutto, hanno lo stesso contenuto di amore e di morte di qualunque racconto, ma fin da L’arrêt de mort appare il gioco temibile della creazione letteraria capace di separare lo scrittore dal mondo, equiparandolo, nell’ambito del mondo stesso, alla morte. Stranamente, le ultime parole di L’arrêt de mort fanno intravedere la figura dello scrittore e del suo tormento, o almeno la figura che egli assumerebbe nella visione di un lettore rimasto sconcertato dal finale del libro, in cui si esprime la totalità dell’accordo fra due esseri. La visione in sé è fatta per sconcertare soprattutto chi deve giudicare in base a un frammento arbitrariamente staccato da un libro.
«Nell’oscurità – scrive Blanchot – [il lettore] mi vedrebbe, la mia parola sarebbe il suo silenzio, ed egli crederebbe di regnare sul mondo, ma questa sovranità sarebbe ancora la mia, il suo nulla il mio, ed anche lui saprebbe che non c’è fine a partire da un uomo che vuol finire da solo.
Che ciò venga dunque ricordato a chi leggesse queste pagine credendole attraversate dal pensiero della sventura. E più ancora, che egli provi ad immaginare la mano che le scrive: se la vedesse, forse leggere diventerebbe per lui un compito serio».
Sono parole oscure: nulla potrebbe renderle chiare. La voce dello scrittore, che è la morte, che viene da un altro mondo, ha un’indubbia autenticità, e solo Blanchot trova la forza di farcela ascoltare.
In questo linguaggio così oscuro, e tuttavia risoluto, c’è un movimento che prolunga, amplificandola, la creazione del linguaggio più perentorio. Tale movimento di creazione può certo essere analizzato, ma non è una filosofia, è il movimento che introduce la negazione del mondo il cui sviluppo drammatico è – come volle esserlo la filosofia – la risposta alla domanda. Risposta evidentemente poco comprensibile. Ma non si tratta più di comprendere l’essere, si tratta di procedere il più lontano possibile in un’esperienza che ci è aperta. L’esperienza del più lontano è la cosa più disarmante, non è necessaria, non è un dovere che ci venga imposto. Ma allo stesso modo in cui l’acqua dei fiumi si dirige verso il mare, tale esperienza è l’abisso a cui tendono la letteratura e il pensiero.
Questo è ciò che era possibile dire di un’opera di difficile accesso, ma che senza dubbio è la più strana del nostro tempo.
______________________________
[N. d. T.] Il brano blanchotiano Le retour, pubblicato in «Botteghe oscure», n. 7, 1951, corrisponde alla parte iniziale del racconto Au moment voulu, Paris, Gallimard, 1951; 1982, pp. 7-25; questa traduzione è stata pubblicata una prima volta in «Scriptions», n. 5, 2000. Il saggio di Bataille, di datazione incerta, era destinato a una rivista di lingua inglese; non incluso nelle Œuvres complètes dell’autore edite da Gallimard, è apparso postumo in «Gramma», n. 3-4, 1976, ed è stato poi ripreso nel volume: G. Bataille, Une liberté souveraine, Tours, Farrago, 2000, pp. 65-73. Il passo di Blanchot citato nel saggio è tratto da una sorta di avvertenza finale di L’arrêt de mort, presente solo nella prima edizione dell’opera (1948) e soppressa a partire dalla seconda (1970). [Giuseppe Zuccarino]
______________________________
***
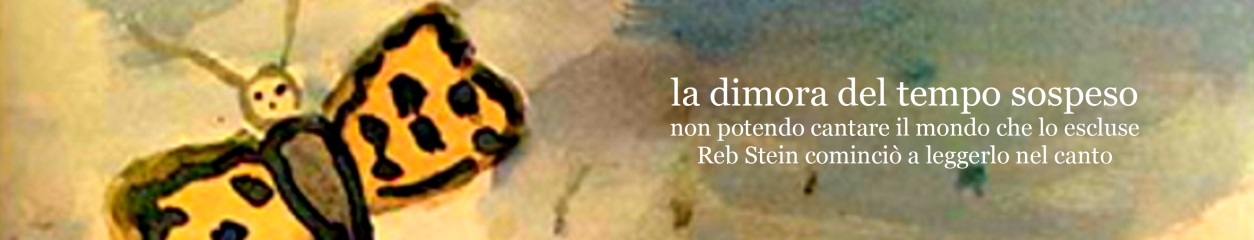

Conoscevo il racconto di Blanchot ma non il bellissimo saggio di Bataille. Il suo modo di “fare critica”, il suo modo di parlare di un autore dichiarato oscuro come Blanchot, mi sembra avvincente e risoluto, quasi marziale per l’energia con cui vuole inquadrare il suo obiettivo. Direi che, in questo caso, è l’idea che genera lo stile. Avere idee è sempre necessario. L’energico e nitido Bataille penetra nel mondo infero e spettrale di Blanchot e cerca delle chiavi intepretative che non riducano l’autore a una tesi personale ma cerchino di coglierne l’essenza. E’ esattamente ciò che non accade quasi mai nel mondo scialbamente facile o inutilmente complesso della scrittura critica contemporanea.
Grazie della lettura.
Marco
casomai fosse necessario ribadirlo, questa è l’ennesima controprova dell’assoluta necessità che questo blog esista.
grazie!
Meditazioni fondamentali. Dove è il lettore, sempre, spesso vanamente, ad inseguire le tracce, scure di piogge notturne, lasciate da chi scrive. Penso agli scrittori che oggi si spintonano – nei vari Strega e Campiello – per mettersi in luce, perennemente tesi ad inseguire il lettore. Che involuzione. Bisogna ripartire da qui, da questi testi lontani per evocare quel profumo di cose nuove, rivoluzionarie che non riusciamo più a trovare nei testi di tanti contemporanei.
Quello che dice Enzo Campi lo sottoscrivo in pieno (comprese naturalmente le osservazioni di M.Ercolani e I.Crico).
Questo racconto mi fa un po’ l’effetto di cui diceva Roland Barthes, del “leggere alzando la testa”, che raccontavi nel post su “la lettura impossibile”.
Perciò, aggiungo solo che secondo me, il fatto che donna si chiami Judith (Giuditta) la dice davvero lunga..
Ciao!
Vi ringrazio per quello che scrivete e, soprattutto, per la vostra presenza qui.
fm