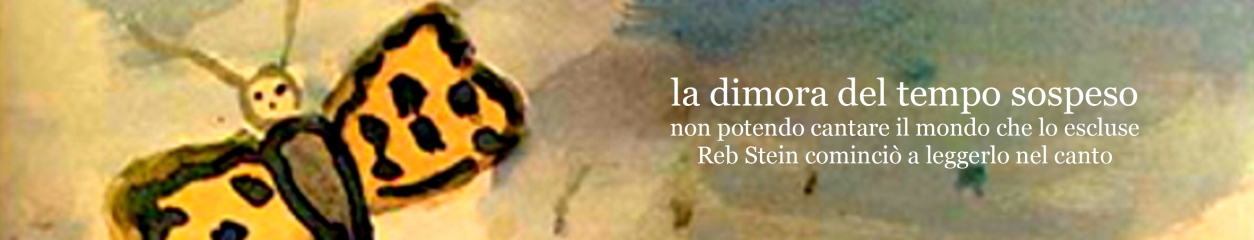*
Continua a leggere Ogni giorno è oggi (II)Tutti gli articoli di Antonio Devicienti
“Mi piace scrivere a te” (di Rocco Brindisi)
*
Lettera d’amore a Totò (di Rocco Brindisi)

Per versi polimorfi / Il Belzebù bambino di Davide Cortese
di Lorenzo Mari
Una poesia che procede per versi polimorfi accenna, per la verità fugacemente, alla mimesi della celebre definizione freudiana di una specifica fase dell’infanzia nello sviluppo psicosociale dell’individuo, per poi darne una rappresentazione che oscilla tra la burla e il grottesco; in questo modo, inoltre, si evita di ricadere nella più banale reiterazione – sempre più destituita, ormai, delle sue motivazioni originali – del fanciullino di pascoliana memoria. L’infanzia (che viene in questo modo, e per paradosso, ad esser considerata assai seriamente) si rivela così essere un repertorio altro, non di rado straniante, al quale sembra avere attinto Davide Cortese per il suo libro più recente, Zebù bambino (Terra d’Ulivi, 2021). Continua a leggere Per versi polimorfi / Il Belzebù bambino di Davide Cortese
Conversazione a Roca Vecchia (da “Iuncturae”)
È un buon luogo, questo, per ritrovarsi a conversare: il mare invernale, lasciato finalmente solo, si dà in tutta la sua austera significanza ed è parca, commovente la sua bellezza priva dei facili trionfi dell’estate.
«Ho sempre amato questi luoghi del passaggio, questi approdi momentanei da cui ripartire».
Accosta il pollice, l’indice e il medio (tra i quali è accesa una sigaretta) alla tempia destra e con l’anulare dell’altra mano percorre più volte l’orlo del bicchiere.
«Sì, capisco e qui il passaggio tra una sponda e l’altra è stretto, i nomi si richiamano tra una riva e l’altra e pure gli dèi (e i demoni) non sono stranieri gli uni agli altri».
[continua a leggere su Iuncturae]
Quaderni delle Officine (CXXII)
Quaderni delle Officine CXXII. Dicembre 2022
Giuseppe Zuccarino I paradossi del dono e della confessione in Baudelaire
*
Derrida legge Baudelaire
Ho l’onore e il piacere di proporre un nuovo saggio di Giuseppe Zuccarino. Lo studioso indaga i sempre stimolanti e originali contributi di Jacques Derrida questa volta relativi a Charles Baudelaire; Zuccarino continua così le proprie ricerche intorno alla luminosa e feconda presenza del pensiero francese del XX Secolo. [A. D.]
I paradossi del dono e della confessione in Baudelaire.
All’origine del primo volume di Donner le temps di Jacques Derrida, c’è un seminario tenuto all’École normale supérieure di Parigi nel 1977-78. In seguito, una parte delle sedute del seminario è stata trasformata in una serie di conferenze esposte all’Università di Chicago nel 1991: sono queste a costituire la base del libro. Alla problematica del dono il filosofo aveva già accennato in vari volumi anteriori, ma in questo caso essa assume un ruolo centrale.
Che l’idea di dono sia sempre inscindibile da una qualche forma di paradosso viene suggerito da Derrida fin dall’inizio. Egli infatti esordisce commentando una frase di Madame de Maintenon, sposa morganatica di Luigi XIV, che in una lettera a un’amica scriveva: «Il re prende tutto il mio tempo; io dono il resto a Saint-Cyr, a cui vorrei donarlo tutto». Ricordiamo per inciso che il verbo donner, oltre che con «donare», si può rendere in italiano in altri modi, come ad esempio «dare» o «concedere». Quanto a SaintCyr, è il nome di un’istituzione voluta dalla stessa Madame de Maintenon e destinata all’«educazione delle fanciulle povere e di buona famiglia. La sua fondatrice vi si ritirò e poté senza dubbio dedicarle tutto il suo tempo, secondo l’auspicio da lei dichiarato, alla morte del re, nel 1715». Benché la frase epistolare sia facilmente comprensibile, resta però bizzarra, e in apparenza illogica nel modo in cui è formulata: infatti, se tutto il tempo della dama di corte viene preso e occupato dal re, come può lei riservarsene un resto per donarlo a Saint-Cyr? Inoltre, a rigore, non il tempo in quanto tale può appartenere a qualcuno, ma soltanto ed eventualmente la scelta sul modo di impiegarlo. […]
Leggi il saggio completo di Giuseppe Zuccarino in
“Quaderni delle Officine”, CXXII, dicembre 2022.
*
Opus tessellatum / 2 (da “Iuncturae”)
 LA REGINA DI SABA (Parla il Re Salomone che, nel mosaico otrantino, le siede di fronte, ma in un altro medaglione)
LA REGINA DI SABA (Parla il Re Salomone che, nel mosaico otrantino, le siede di fronte, ma in un altro medaglione)
«Signora del viaggio, mente che avida contempla la mia città, ti sono grato del dono che porgi a me pur non-sapiente – ma sapienza (sappilo) è cercare sapienza. Il tuo viaggio t’ha edotta, tu già sul sentiero per la sapienza nel momento in cui decidesti e apparecchiasti la partenza.
[continua a leggere su Iuncturae]
To sxedio
“Questo spazio dove non sei” di Domenico Brancale
memoria video di Celia Notarbili
montaggio di Jacopo Gandolfi
ambiente sonoro di Federico Pipia
Il video è stato realizzato all’interno dell’installazione site specific “Mariuccia” di Giuseppe Di Liberto, in occasione della mostra Colostro (19 artisti presso la Torre) a cura di Giulia Mariachiara Galiano e Riccardo Vailati, Torre Massimiliana di Sant’Erasmo (Venezia 2022).
Per una lettura di “Perdite”
Chiara Catapano legge Perdite (Puntoacapo Editrice) di Bartolomeo Bellanova.
“Quale incendio indomabile si prepara nei fondali!” (Dispaccio da Vieste)
Ho voluto iniziare da questa profezia, quell’indomabile incendio che illumina e purifica, di cui Bellanova percepisce il propagarsi nei fondali: un incendio che si innesca dalle profondità oscure, da luoghi impensabili, per ossimoro. In fin dei conti, mi sono detta, questo è un libro di profezie che si stanno avverando mentre si scrivono. E’ come l’incontro tra due mari, tra due sostanze identiche ma provenienti da diversi luoghi; è il momento in cui il futuro annunciato e il passato veggente si salutano, generando immagini. Continua a leggere Per una lettura di “Perdite”
Friedrich Hölderlin, La veduta (dalle “Nature indivisibili”)
LA VEDUTA Quando la vita abitante degli umani si avvia nella lontananza, là dove s’illumina lontanando il tempo delle vigne, le è contemporaneo anche il campo vuoto dell’estate, il bosco si profila con la sua oscura figura; che la natura completa l’immagine dei tempi, ch’essa dura, quelli scivolano via veloci, è cosa che accade per perfezione, l’altezza del cielo sfolgora allora sull’essere umano, come la fioritura incorona gli alberi. Con umiltà Scardanelli 24 maggio 1748
[continua a leggere sulle Nature indivisibili]
Da un libro a venire di Nino Iacovella
 Nino Iacovella acconsente alla pubblicazione di un’anticipazione di un libro che ho avuto il privilegio di leggere in anteprima: La parte arida della pianura.
Nino Iacovella acconsente alla pubblicazione di un’anticipazione di un libro che ho avuto il privilegio di leggere in anteprima: La parte arida della pianura.
Una scrittura controllatissima e rigorosa, un’idea di poesia aliena da ogni narcisismo e lirismo, una rara lucidità di pensiero e di giudizio innerva pagine destinate a segnare la scrittura in poesia del tempo che stiamo così angosciosamente attraversando.
La scrittura di Nino è istanza di libertà e intransigente scelta etica, politica, resistenziale.
La lavanderia (di Rocco Brindisi)
 Scendo in lavanderia con un bustone di panni. Mi porto le “Lettere di Don Milani” per ingannare l’attesa e perché questo libro è una delle letture più avvincenti di questi ultimi mesi: la bellezza dolorosa della lingua, l’ostinazione, fraterna, a ragionare sulle parole, sui fatti. Don Milani è malato, costretto a letto, è lì che scrive, credo usi un quaderno, immagino grande, e una biro. Il suo amore, testardo, per i poveri, per i dannati della terra.
Scendo in lavanderia con un bustone di panni. Mi porto le “Lettere di Don Milani” per ingannare l’attesa e perché questo libro è una delle letture più avvincenti di questi ultimi mesi: la bellezza dolorosa della lingua, l’ostinazione, fraterna, a ragionare sulle parole, sui fatti. Don Milani è malato, costretto a letto, è lì che scrive, credo usi un quaderno, immagino grande, e una biro. Il suo amore, testardo, per i poveri, per i dannati della terra.Poesia e consapevolezza. Sui libri di Fabrizio Miliucci e Antonio Francesco Perozzi
di Lorenzo Mari
Pochi giorni fa riflettevo con un amico poeta sull’aura di “consapevolezza” che viene spesso ricercata, tanto da chi scrive quanto da chi legge, nelle scritture poetiche degli “esordi”, o comunque in quelle di chi è nei propri venti, e ormai anche trent’anni – nella cosiddetta “poesia giovane”, per capirci. “Consapevolezza” è, ovviamente, un termine ingenuo e attinente più che altro al senso comune, ma non manca di avere precisi addentellati culturali e formali nella produzione poetica in oggetto, che non di rado si trova a oscillare, senz’alcuna soluzione di continuità, tra l’immediatezza apparentemente più viscerale e la sofisticazione più chiaramente sovrastrutturale. D’altronde, quest’ultimo dato – in mancanza di motivi non soltanto di innovazione, ma anche di complessità, nella poesia contemporanea più in generale – si offre come un’inevitabile chiave d’accesso a un certo capitale simbolico. (Un capitale che consente, peraltro, di scrollarsi progressivamente di dosso l’aggettivo “giovane”, che non è poco…). Continua a leggere Poesia e consapevolezza. Sui libri di Fabrizio Miliucci e Antonio Francesco Perozzi
Una carena e le ragioni dell’antifascismo
Opus tessellatum / 1 (da “Iuncturae”)
 (parla la creatura che regge sulla testa la scacchiera)
(parla la creatura che regge sulla testa la scacchiera)
«Chi adesso scrivendo mi dà la parola lo ricordo bambino entrare in questo grande spazio figurato, camminare su questo tappeto di mosaico e, nella fascinazione del suo non capire, immergersi negli enigmi che mai gli si sarebbero dissolti, ma proprio per questo ancora restano luminosi e fascinanti.
Nell’animalità delle mie quattro zampe, nell’umanità del mio volto, nel sapiente trifoglio che, trino e germogliante, è figura della parola, reggo quest’enorme scacchiera e mostro così la geometria del vivere e del morire, dell’andare e del restare, squaderno la corrispondenza perfetta tra le speculazioni della mente e l’universo indagato e interrogato.
[continua a leggere su Iuncturae]
L’eternità a Lourmarin (dalle “Nature indivisibili”)
 Non esiste più né linea diretta né strada illuminata che mi leghino a colui che mi ha appena lasciato. Contro che cosa va a stordirsi il mio affetto? Cerchio dopo cerchio, s’egli s’avvicina è per subito allontanarsi. Talvolta il suo viso viene ad appoggiarsi al mio: e suscita soltanto un gelido lampo. Non esiste più da nessuna parte la giornata che prolungava la felicità tra lui e me. Ogni parcella – quasi in eccesso – della sua presenza si è all’improvviso dispersa. Abitudine della mia vigilanza… Tuttavia quest’essere venuto meno perdura in un qualcosa di rigido, di deserto, d’essenziale in me, dove i millenni vissuti insieme formano soltanto lo spessore d’una palpebra chiusa.
Non esiste più né linea diretta né strada illuminata che mi leghino a colui che mi ha appena lasciato. Contro che cosa va a stordirsi il mio affetto? Cerchio dopo cerchio, s’egli s’avvicina è per subito allontanarsi. Talvolta il suo viso viene ad appoggiarsi al mio: e suscita soltanto un gelido lampo. Non esiste più da nessuna parte la giornata che prolungava la felicità tra lui e me. Ogni parcella – quasi in eccesso – della sua presenza si è all’improvviso dispersa. Abitudine della mia vigilanza… Tuttavia quest’essere venuto meno perdura in un qualcosa di rigido, di deserto, d’essenziale in me, dove i millenni vissuti insieme formano soltanto lo spessore d’una palpebra chiusa.
Ho smesso di parlare con colui che amo – eppure non è il silenzio. Che cos’è allora? Lo so, o credo di saperlo. Ma soltanto quando il passato, che ha un significato, s’apre per lasciarlo passare. Eccolo alla mia altezza, poi lontano, davanti.
Nell’ora nuovamente raccoltasi – allorché interrogo tutto il peso dell’enigma – all’improvviso comincia il dolore, quello del compagno per il compagno, che l’arciere, stavolta, non sa trapassare.
[continua a leggere sulle Nature indivisibili]
Ancora notte (di Rocco Brindisi)
Nel martello del cervello: su “Ludwig” di Andrea Leone
 Anche questa volta si pensa al Manfred incarnato da Carmelo Bene, agli spasmodici recitativi del Tristan und Isolde di Wagner, alle affermazioni vertiginose di assoluto del Prinz von Homburg di Kleist mentre si leggono le sequenze di Ludwig di Andrea Leone (Fallone Editore, Taranto 2022) che ripete le altezze e le sontuosità del dire già raggiunte in Hohenstaufen e in Kleist – e si ha l’impressione di essere davanti a una “trilogia tedesca” nella quale si compie il miracolo di poter leggere in italiano sequenze di testi che, se fossero scritti in tedesco, avrebbero la stessa forza espressiva e concettuale, il medesimo ritmo antiretorico eppure sapientemente condotto secondo l’arte del dire e dell’argomentare. [continua a leggere su Via Lepsius]
Anche questa volta si pensa al Manfred incarnato da Carmelo Bene, agli spasmodici recitativi del Tristan und Isolde di Wagner, alle affermazioni vertiginose di assoluto del Prinz von Homburg di Kleist mentre si leggono le sequenze di Ludwig di Andrea Leone (Fallone Editore, Taranto 2022) che ripete le altezze e le sontuosità del dire già raggiunte in Hohenstaufen e in Kleist – e si ha l’impressione di essere davanti a una “trilogia tedesca” nella quale si compie il miracolo di poter leggere in italiano sequenze di testi che, se fossero scritti in tedesco, avrebbero la stessa forza espressiva e concettuale, il medesimo ritmo antiretorico eppure sapientemente condotto secondo l’arte del dire e dell’argomentare. [continua a leggere su Via Lepsius]